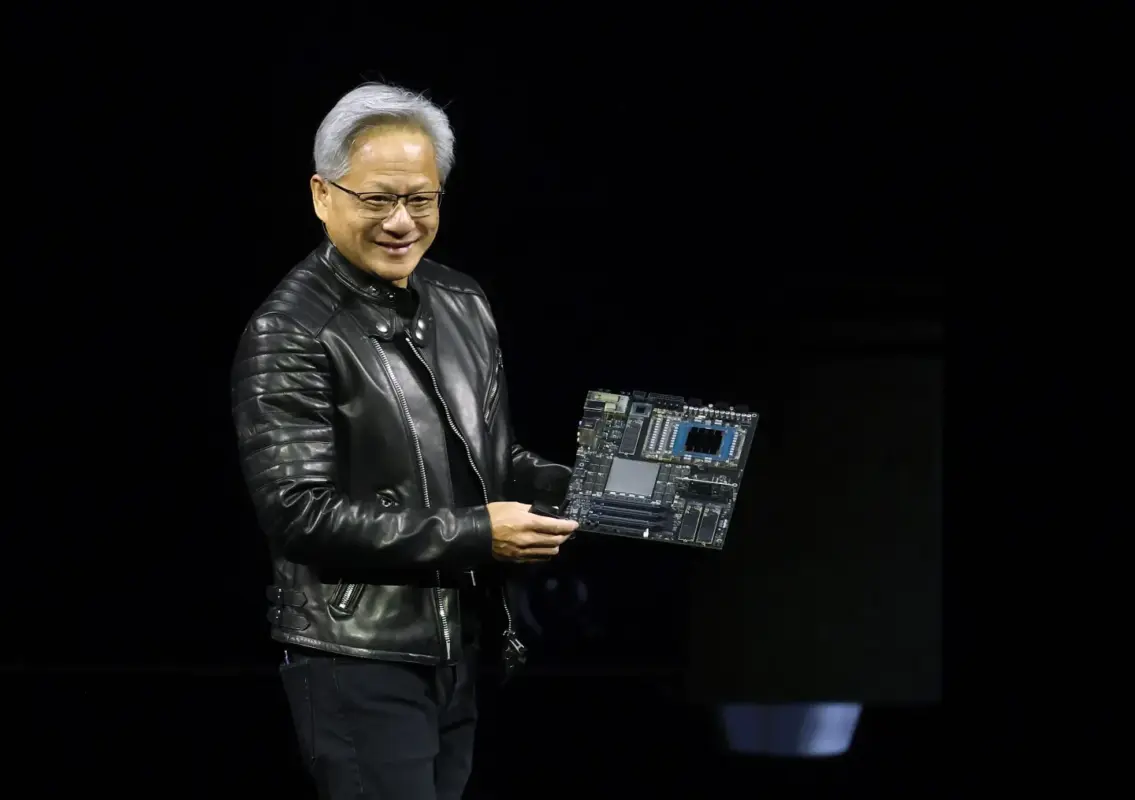La francese Eutelsat è al centro di un improvviso rilancio di prospettive. Il valore delle sue azioni è triplicato in pochi giorni. Un’operazione sapientemente orchestrata da un’Ue che riscopre la volontà di indipendenza geostrategica rispetto alle tecnologie americane sul segmento decisivo delle comunicazioni satellitari.
Si è proposta sia a Kiev sia all’Italia come alternativa in ambito militare e civile. Il ragionamento è chiaro: sta facendo leva sul rischio di affidare un’infrastruttura strategica a un imprenditore privato come Musk. Ma non ha le economie di scala di Starlink, né è in grado di garantire la copertura e gli investimenti che l’imprenditore di origini sudafricane si appresta a fare.
Comprensibile che i francesi vogliano sfruttare una rendita di posizione. Fanno parte del progetto appena lanciato dalla Ue in qualità di soggetto-pivot. Nome in codice: Iris 2. Una costellazione da 290 satelliti tra orbita media e bassa.
Il primo contratto da 10 miliardi con il consorzio che la dovrebbe realizzare, di cui le italiane Thales Alenia e Telespazio sono i principali fornitori, è stato siglato qualche settimana fa. Ma le incognite, tecniche e di costo, sono enormi.
Con i tempi già slittati di tre anni, al 2030, proprio perché Eutelsat non è in grado di avere una capacità produttiva analoga a quella americana.
Quel che è certo è che la corsa alle comunicazioni civili e militari dall’orbita bassa (in inglese Leo, tra 500 e 1.200 chilometri di altitudine) sta per avere un’accelerazione.
Se tutti rispettassero gli obiettivi, stima Goldman Sachs, il numero di satelliti in orbita triplicherebbe nei prossimi cinque anni a 30 mila, e nei successivi cinque a quota 80 mila.
Un gran traffico, prodotto da varie evoluzioni tecnologiche. Rispetto ai tradizionali e mastodontici satelliti geostazionari, che orbitano a migliaia di chilometri di altezza, quelli di orbita bassa pesano appena 330 chili, più economici da costruire e lanciare.
L’antenna necessaria a ricevere il segnale ha un costo di produzione inferiore a 600 dollari. La latenza, lo scarto temporale perché il segnale si colleghi alla rete, si è molto ridotta ed ora è compresa tra 25 e 60 millisecondi (quella di una rete 5G è tra i 5 e i 20).
Tutto questo ha reso la connessione satellitare un business competitivo. Per le zone poco abitate, dove mancano infrastrutture alternative di rete fissa o mobile, in mare aperto, o ancora come strumento di comunicazione “di riserva” da attivare in caso di disastri naturali o conflitti.
Musk però da tempo offre entrambi i servizi. E’ partito prima, ha investito di più, ha già in orbita 7 mila satelliti e nel 2025 progetta di lanciarne altri 180.
La legge italiana già apre a Starlink la possibilità di entrare nei bandi Pnrr per portare la connessione ultraveloce nelle aree rurali del Paese. In quelle “grigie”, a parziale fallimento di mercato, l’ex Tim Fibercoop (venduta al colosso Usa Kkr) e Open Fiber (controllata dalla pubblica Cdp) gestiscono 1,8 miliardi di fondi Ue, ma finora hanno collegato solo un terzo degli edifici previsti.
A dicembre è partita una prima sperimentazione in Lombardia per testare il sistema, che è già commercializzato in Italia con 40 mila clienti.