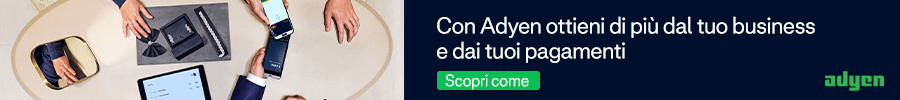“Il Dna non delude mai”. Classe 1959, Giuseppe Novelli è nato sei anni dopo la scoperta della doppia elica. Con in tasca una laurea in Scienze biologiche – e una curiosa pubblicazione sul comportamento delle mantidi religiose – è stato folgorato sulla via della genetica medica, anche grazie a maestri come il professor Bruno Dallapiccola (celebre genetista che, nei primi anni 2000, fece scalpore suggerendo che fino al 10% dei bebè nati in Italia ogni anno avesse un papà diverso da quello presunto).
“Ho visto crescere la genetica dagli inizi, quando Renato Dulbecco aveva appena lanciato il Progetto genoma”, ricorda Novelli, già rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, dove oggi è ordinario di Genetica medica.
Impegnato nella mappatura e nell’identificazione di malattie rare senza nome, lo scienziato è autore di circa 700 pubblicazioni scientifiche (molto citate a livello internazionale). Ha introdotto in Italia l’analisi del Dna a uso forense e, insieme al suo gruppo di ricerca, ha sviluppato protocolli e piattaforme per esaminare le tracce genetiche sulla scena del crimine.
“Il mio sogno nel cassetto – confida – è quello di dare ancora un contributo con qualche scoperta importante. Magari identificando una malattia oggi senza nome”.
Quali sono i filoni più interessanti della ricerca per il 2025?
I farmaci a Rna e le nuove sperimentazioni di questa tecnologia per malattie genetiche e altre patologie. Ma vedremo anche consolidarsi la scoperta di Huji Xu della Naval Medical University di Shanghai, che quest’anno ha sviluppato nuovi trattamenti per alcune gravi malattie autoimmuni usando cellule T derivate da donatori e modificate geneticamente.
Una sorta di Car-T progettata non per sconfiggere i tumori, ma per le malattie autoimmuni, che è stata definita una delle 10 scoperte del 2024 da ‘Nature’. Si tratta di una novità assoluta: pensiamo all’impatto in patologie come artrite reumatoide e psoriasi. Mi aspetto grandi cose anche sul fronte della medicina di genere, in particolare nella diversa risposta ai farmaci. Nel 2024 sono emerse 5-6 scoperte ‘chiave’ dal punto di vista biologico, che hanno permesso di capire perché le donne sono più resistenti alle infezioni, ma anche più suscettibili alle malattie autoimmuni. Questo cambierà il paradigma, secondo me, sia per i farmaci che per vaccini.
È finita l’epoca della pillola uguale per tutti. Se nel 2024 ci sono state le scoperte, nel 2025 mi aspetto le prime applicazioni.
Dna e ambiente: in che modo ciò che ci circonda influisce sulla nostra salute?
Il rapporto si sta chiarendo: abbiamo visto che nelle città l’inquinamento luminoso, quello chimico e quello atmosferico fanno una bella differenza sulla salute degli abitanti. Abbiamo grandi banche dati biologiche e archivi di dati clinici che ci consentono di misurare e comprendere meglio l’impatto di alcuni fattori ambientali sul Dna.
Un caso eclatante è legato allo zucchero: nelle persone nate nel 1953 c’è stato un aumento del 30% dei casi di diabete e ipertensione rispetto alla generazione precedente, proprio per via della diffusione di questo dolce alimento.
Insomma, la salute è scritta nel Dna ma quest’ultimo non è mai nudo nelle cellule: il suo vestito è l’ambiente, l’epigenetica. Tutto quello che respiriamo e mangiamo influenza il genoma, facendolo funzionare in maniera diversa. Capiremo sempre meglio come regolare questo ‘vestito’, che è fatto anche di Rna. Gli interruttori dei geni si celano nell’ambiente. Ecco perché l’esposoma, l’esposizione all’ambiente lungo tutta una vita, è bersaglio di molte ricerche.
Lei è stato il perito di numerosi casi celebri, come quello di Via Poma e l’omicidio di Meredith Kercher. Oggi, anche grazie alle piattaforme di streaming, siamo diventati un po’ tutti genetisti: istruzioni per l’uso?
È un bene: oggi non si può fare a meno della genetica. Pensiamo alla storia di Marie-Claire King, scopritrice del gene BRCA1: lei non avrebbe mai immaginato che il 35% dei casi di tumore al seno è dovuto a mutazioni di questo gene.
Oggi saperlo vuol dire poter fare prevenzione ed evitare il cancro. Pensiamo ai farmaci: ormai sappiamo che la reazione avversa ai medicinali è scritta nel Dna. Da quando ci sono i test genetici abbiamo avuto in Europa il 30% in meno di casi di eventi avversi ai farmaci, che ogni anno uccidono moltissime persone nel mondo.
Oggi è in corso una rivoluzione, quella dell’Ai. In che modo sta impattando sulla genetica?
In questo Paese un po’ tutti parlano di intelligenza artificiale, ma quelli che ci lavorano davvero sono gli americani e i cinesi. Dovremmo studiare di più, approfondire, capire. Insomma, secondo me occorre investire in chi fa l’Ai, non in chi ne parla, o preoccuparci solo delle regole.
Questo è un punto cruciale. Non dimentichiamo poi che i ‘suggerimenti’ dell’AI vanno dimostrati e molto dipende da come implementiamo la tecnologia. In ogni caso penso che alla fine nel nostro campo l’intelligenza artificiale darà risultati importanti, che ci aiuteranno a leggere il genoma più rapidamente, anche se non si potrà fare a meno del genetista che li interpreti. Insomma, ben venga ma a patto che ci sia sempre il copilota.
C’è una grossa spinta verso l’approccio One Health in medicina, cosa ne pensa?
La multidisciplinarietà è fondamentale. La salute non ha confini e la ricerca più dirompente emerge quando più specialisti diversi si uniscono.
Nel corso della sua lunga carriera di ricercatore le è mai capitato un caso di serendipity?
Una delle mie scoperte più famose è frutto di serendipità (un particolare tipo di fortuna dovuta anche a sagacia, spirito e capacità di osservazione, ndr). È accaduto quando abbiamo individuato la causa genetica di una rara malattia, la sindrome di Andy Gump.
Una scoperta che aprì la strada a numerose ricerche sulle lipodistrofie e su diverse malattie dell’invecchiamento. Nel 1986 alcuni colleghi ortopedici mi segnalarono il caso di un paziente con una malattia strana, che aveva girato mezza Italia per una diagnosi.
Ci siamo interessati a questa patologia, colpiti soprattutto dal fatto che tutti o quasi i casi descritti in letteratura (circa 20, all’epoca) erano italiani o di origine italiana. Abbiamo isolato il difetto genetico, testandolo su un topo transgenico e dimostrando così che l’animaletto invecchiava subito.
In seguito abbiamo scoperto che le alterazioni della lamina causano decine di malattie ereditarie diverse, ognuna con una storia differente, complessivamente oggi denominate ‘laminopatie’.
Facciamo un passo indietro: quando era bambino che lavoro avrebbe voluto fare da grande?
Il ricercatore naturalistico. Lo sto raccontando in un libro che sto scrivendo e uscirà quest’anno. Fin da giovanissimo ero attratto da tutto ciò che è vivente: il primo articolo che ho scritto riguardava gli insetti, le mantidi religiose. Volevamo capire perché la femmina mangiasse il maschio dopo l’accoppiamento. All’epoca con un collega abbiamo testato la nostra teoria: se davamo da mangiare dei grilli alla mantide dopo l’accoppiamento, lei non divorava più il maschio. Evidentemente, era una questione di fonti proteiche.
Che consiglio darebbe ai giovani che si avvicinano alla professione?
In effetti li invidio: non si rendono conto del momento in cui stanno vivendo. Quando noi abbiamo iniziato non avevamo telefonini, computer, AI, email. Per parlare con un collega americano dovevo scrivergli una lettera. Oggi il mondo è straordinario, abbiamo i farmaci a Rna, una conoscenza di ciò che accade dentro le singole cellule, organoidi artificiali che ti permettono di studiare il cervello in laboratorio.
Insomma, i giovani ricercatori avranno a disposizione tecnologie straordinarie e in questo modo lo studio del Dna e l’immunologia cambieranno la salute e la medicina. Anzi, già lo stanno facendo. Oggi abbiamo terapie geniche che guariscono patologie incurabili fino a pochi anni fa: è davvero bellissimo.