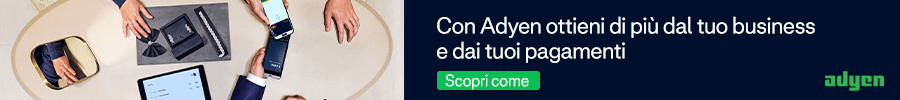Una frase nei libri di storia. Ma è davvero possibile rimuovere dalla memoria la ‘calamità’ che tolse la vita a circa 7.500 ebrei italiani? Le parole della senatrice Liliana Segre gettano un’ombra lunga sul Giorno della memoria della Shoah, che arriva quando non c’è ancora pace in Israele e la tregua mostra tutta la sua fragilità.
Il fatto è che la memoria degli uomini è forse altrettanto fragile, non solo per colpa delle tante malattie neurologiche che incombono su una popolazione che invecchia. Se non alimentiamo la memoria, infatti, c’è il rischio che un giorno la Shoah venga completamente dimenticata “e sia ridotta a una frase nei libri di storia”, come ha detto Liliana Segre.
Allora forse faremmo bene a far tesoro di questo monito, che la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz ha confidato in un’intervista con Marco Vigevani, presidente del comitato eventi del Memoriale della Shoah – online sul sito del Memoriale e su Corriere.it – e riannodare il filo dei ricordi, perchè si rinnovi la testimonianza di ciò che è accaduto. Magari con l’aiuto dell’arte, della cultura e della scienza.
La Shoah della scienza e della cultura
Questo è il giorno per rievocare storie di creatività, immaginazione e coraggio che arrivano dal mondo della scienza e della medicina. Storie interessati ma ormai quasi dimenticate, come la ‘bufala’ del Morbo di K, che salvò tante vite umane. Ma facciamo un passo indietro: perchè, non solo in Italia, la Shoah travolse anche la scienza. Con tanti medici e ricercatori privati del camice o allontanati dalle università e dai centri di ricerca.
Talenti della scienza che in alcuni casi hanno perso la vita, in altri sono poi divenuti celebri, come il futuro premio Nobel Rita Levi-Montalcini: espulsa dall’Università di Torino nel 1938, a Firenze la giovane studiosa (classe 1909) allestì un laboratorio nella sua camera da letto pur di continuare la sua ricerca.
Un morbo misterioso
Ma cosa può fare la scienza contro l’orrore? In effetti, proprio la conocenza della medicina e della psicologia – grazie a quella che oggi definiremmo una ‘bufala’ – ha aiutato a salvare vite umane. Per rafforzare la memoria della Shoah, può essere allora un piccolo esercizio salutare ricordare la storia del Morbo di K, che i lettori di Fortune Italia hanno imparato a conoscere anche grazie al racconto di Dario Manfellotto, presidente della Fondazione Fadoi e per molti anni direttore del Dipartimento di Medicina interna dell’ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina.
“Era la mattina del 16 ottobre 1943, l’inizio del rastrellamento al ghetto. Decine di persone cercarono riparo al vicino ospedale Fatebenefratelli. Arrivati sull’Isola furono accolti dal medico Vittorio Sacerdoti e dal primario di Medicina interna Giovanni Borromeo, e quest’ultimo decise di ricoverarli tutti”, ci ha raccontato Manfellotto.
Borromeo, assieme al suo aiuto Adriano Ossicini (medico, psichiatra, poi senatore della Repubblica e ministro) e a Sacerdoti, ideò una malattia infettiva molto grave: “Il ‘Morbo di K’, dove la K stava a indicare l’ufficiale tedesco Herbert Kappler o il generale tedesco Albert Kesselring. Hanno protetto tante persone con questo artificio: i finti ricoverati vennero sistemati in un reparto speciale, in isolamento. Il morbo veniva descritto come una malattia degenerativa molto contagiosa”, ha precisato Manfellotto.
Per i tedeschi, oltretutto, il morbo di K evocava la malattia di Koch, ossia la tubercolosi: i militari ne erano terrorizzati. Anche perché i medici italiani descrivevano una malattia infettiva caratterizzata da convulsioni, paralisi degli arti e morte per asfissia. La paura del contagio allontanò le SS, salvando decine di ebrei.
La Radio nel Tevere, il morbo di K e le pietre dorate: la Shoah della scienza
Le pietre parlanti
Forse, camminando nelle nostre città, avrete notato piccoli quadrati di pietra (10×10 cm), ricoperti di ottone lucente, con nome, anno di nascita, giorno e il luogo di deportazione, data della morte. Sono le pietre d’inciampo ideate dell’artista tedesco Gunter Demnig: ‘sampietrini’ coperti da una piastra d’ottone incisa con i dati dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, posti davanti alla porta delle loro ultime abitazioni. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000, molte sono a Roma, e il loro muto scintillio ci aiuta a ricordare i nomi di chi è stato travolto dal male.
La forza delle immagini
Nella Giornata della memoria il mondo della ricerca chiede aiuto al cinema. Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Università di Pisa, insieme alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, oggi proiettano “Memoria. I sopravvissuti raccontano”, film del 1997 sulla Shoah italiana per la regia di Ruggero Gabbai, con il soggetto di Liliana Picciotto e Marcello Pezzetti.
“Ad Auschwitz erano partiti dall’Italia in 5.644 ed erano tornati in 363, meno del 10%”, scrive la sceneggiatrice Liliana Picciotto, storica della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. “Nel 1994 avevamo ritrovato appunto di loro 93, oggi ne sono vivi pochissimi e questo dà il senso della preziosità del lavoro, della raccolta sistematica delle testimonianze. Non è stato facile trovarli tutti e poi convincere i figli e le mogli che cercavano di proteggerli a ritornare con i ricordi a quel tragico periodo, quando trionfò il nazismo e il fascismo”.
“Fin da subito, nella fase di progettazione del film, decidemmo, noi due autori, io stessa e Marcello Pezzetti, assieme al regista Ruggero Gabbai, di seguire la lezione di Claude Lanzmann nel suo monumentale film Shoah: riportare le persone sui luoghi dei fatti e non intervistarli nelle loro case di oggi. Abbiamo voluto che ognuno ritrovasse un pezzetto di sé stesso di allora. Abbiamo lasciato i testimoni camminare, meditare, parlare con calma, non incalzati dalle nostre domande, dialogare con la loro memoria (…) Questo film è pieno di silenzi, a volte anche i silenzi parlano. Il problema della mancanza di senso della Shoah è lasciato aperto. Questo evento sfugge agli strumenti di analisi dei meccanismi della storia. Si può soltanto provare a spiegare, non a capire. E questo emerge benissimo dallo sguardo dolorante, quasi attonito, dei testimoni”.
Allenare la memoria contro l’indifferenza
Ma cosa succederà quando i testimoni della Shoah non saranno più presenti con noi, per aiutarci a ricordare? “Io sono di natura pessimista e questo certamente non aiuta in questo mio giudizio, ma sono così sicura dentro di me che una volta spariti, e ormai manca poco, gli ultimissimi superstiti e quando sarà finita la generazione dei figli dei superstiti, e dei nipoti forse, man mano che il tempo passerà, sia per la questione di come è stato finora sia per le falsità che verranno dette, così come in 1984 di Orwell, che secondo me dovrebbe essere adottato nelle scuole, la Shoah sarà ridotta a una frase nei libri di storia”, ha detto nella sua intervista con con Marco Vigevani Liliana Segre, temendo la forza dell’indifferenza.
Ecco allora perchè è importante, oggi più che mai, allenare la nostra memoria: storie, ricordi, volti, nomi sono un esercizio per il cervello, che scienza e arte possono aiutare. Perchè, come ha scritto Liliana Picciotto, “l’unica consolazione è che forse la memoria di tutto ciò, serva come baluardo affinché atteggiamenti di chiusura, di incomprensione, di non riconoscimento dei diritti degli altri (…) non abbiano più cittadinanza nel nostro presente”. E nel nostro futuro.
FOTO: Presentazione mostra ’Tu sei la memoria della mia notte’ al Memoriale della Shoah Binario 21, Milano 22 Gennaio 2025 ANSA/MATTEO CORNER