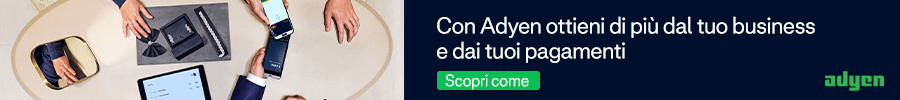Il Dna non delude mai. Questa volta le analisi hanno aiutato storici e archeologi a comprendere meglio cosa accadde in occasione di quello che oggi definiremmo un evento estremo: l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che seppellì la città romana di Pompei e i suoi abitanti sotto uno spesso strato di cenere e lapilli e costò la vita a Plinio il Vecchio.
Quando le loro case crollarono sotto il peso dei lapilli che piovevano come bolidi da molti chilometri di altezza, molti degli abitanti della città persero la vita (sarebbero oltre mille le vittime accertate), e chi sopravvisse alla fase iniziale dell’eruzione, fu ucciso dai devastanti flussi piroclastici, una fuoriscita di materiale magmatico e gas ad alte temperature, che avvolse istantaneamente i loro corpi in uno strato solido di cenere, preservandoli nel corso del tempo. Mentre ancora si indaga sulle effettive cause della morte degli antichi pompeiani, a raccontare una storia interessante sono i calchi realizzati per la prima volta dall’archeologo Giuseppe Fiorelli.
Dal 1800 i calchi, realizzati versando gesso nei ‘vuoti’ lasciati da questi corpi dopo la loro decomposizione, hanno permesso di ricostruire l’aspetto di alcuni gruppi di persone colte negli ultimi istanti di vita. Ebbene, un lavoro pubblicato qualche tempo fa su ‘Current Biology’ ha permesso, proprio grazie all’analisi del Dna estratto dai resti scheletrici pesantemente frammentati incorporati in 14 degli 86 famosi calchi di Pompei (sottoposti a restauro), di stabilire con precisione le relazioni di parentela, determinare il sesso e tracciare l’ascendenza dei soggetti. Con risultati che contraddicono le ipotesi precedenti, basate esclusivamente sull’aspetto fisico, sui gesti e sul posizionamento dei corpi.

Relazioni riscritte
Altro che genitori e figli, o amanti. “Questa ricerca mostra come l’analisi genetica possa aggiungere significativamente alle storie costruite a partire dai dati archeologici”, ha sottolineato il professor David Caramelli, del Dipartimento di Antropologia dell’Università di Firenze. “I risultati sfidano nozioni antiche come l’associazione dei gioielli con la femminilità o l’interpretazione della vicinanza fisica come prova di relazioni familiari”.
“Inoltre le prove genetiche aggiungono un livello di complessità alle semplici narrazioni di parentela. Ad esempio, nella Casa del Braccialetto d’Oro (nella foto principale/Courtesy of Archaeological Park of Pompeii), l’unico sito in cui abbiamo informazioni genetiche relative a più individui, le quattro persone tradizionalmente ritenute i due genitori e i loro figli in realtà non hanno legami genetici tra loro”, ha raccontato Caramelli.
“I dati scientifici che forniamo non sempre sono in linea con le ipotesi più comuni”, ha ammesso David Reich dell’Università di Harvard. “Un esempio degno di nota è la scoperta che un soggetto adulto che indossa un braccialetto d’oro e tiene in braccio un bambino, tradizionalmente interpretati come madre e figlio, erano in realtà un uomo e un bambino senza legami di parentela fra loro. Allo stesso modo, una coppia che si pensava composta da due sorelle, o una madre e una figlia, era composta da almeno un maschio”. Insomma, le ricostruizioni poetiche o le interpretazioni dei gesti vanno decisamente riviste.
“È probabile che l’uso di questi calchi a fini narrativi possa aver portato i restauratori del passato a modificarne le posture e i posizionamenti”, ha aggiunto David Caramelli. “L’uso combinato di dati genetici e altri metodi bioarcheologici ci offre la possibilità di comprendere meglio la vita e le abitudini delle vittime dell’eruzione del Vesuvio”.
Un Impero cosmopolita
Il Dna ha raccontato molto anche sulle origini dei pompeiani, che avevano diversi background genomici. La scoperta che i soggetti discendevano principalmente da soggetti immigrati di recente dall’area del Mediterraneo orientale evidenzia la natura cosmopolita dell’Impero romano.
“Le nostre scoperte hanno implicazioni significative per l’interpretazione dei dati archeologici e la comprensione delle società antiche”, ha detto Alissa Mittnik del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Ma evidenziano anche l’importanza di integrare i dati genetici con le informazioni archeologiche e storiche per evitare interpretazioni errate, basate su ipotesi moderne. “Questo studio sottolinea anche la natura diversificata e cosmopolita della popolazione di Pompei, che riflette modelli più ampi di mobilità e scambio culturale nell’Impero romano”.
Insomma, dopo Rx e diagnostica per immagini, anche l’esame del Dna sta diventando uno strumento prezioso per l’archeologia. E il celeberrimo sito campano può essere apripista. “Il Parco di Pompei include da anni l’analisi del Dna antico nei suoi protocolli di studio, non solo per le vittime umane, ma anche per quelle animali”, ha spiegato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco di Pompei, che nel 2024 ha attirato oltre 4 milioni di visitatori.