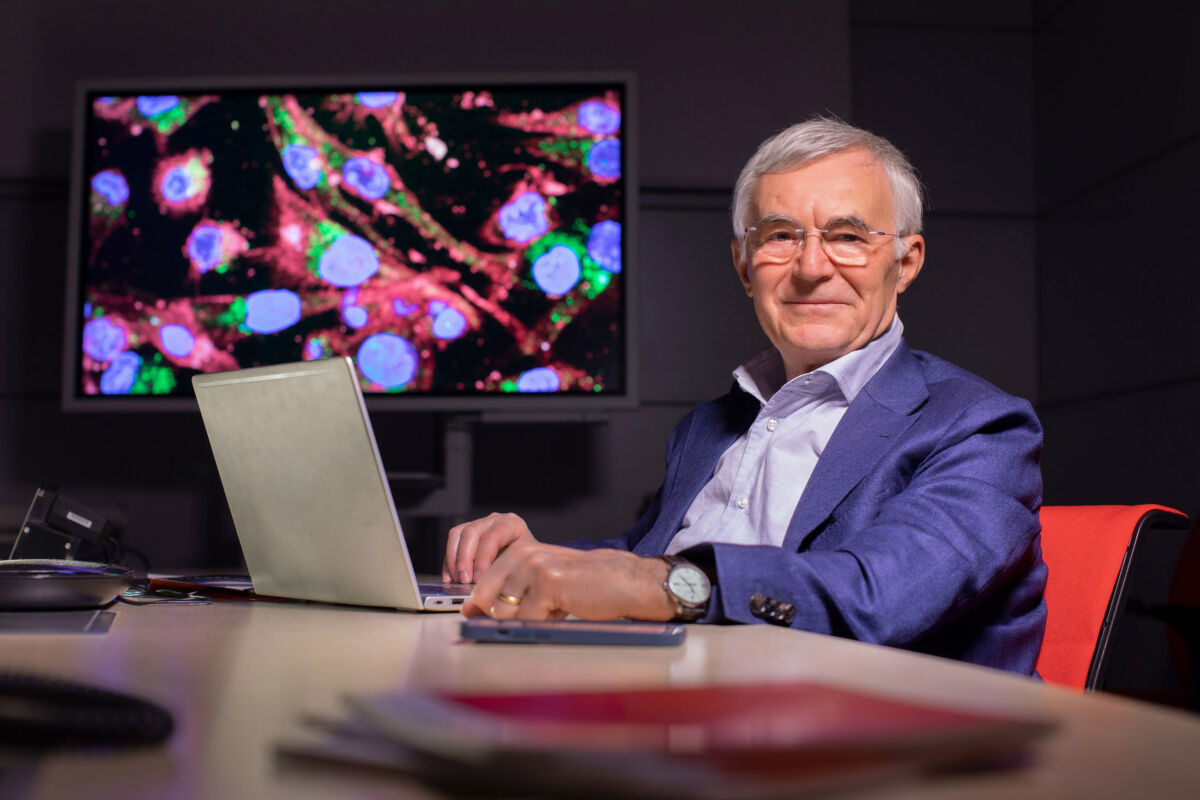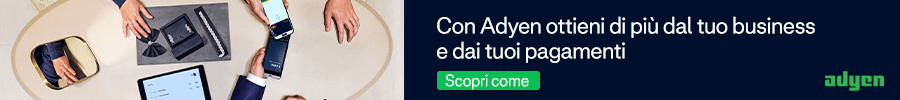Lo scienziato Rino Rappuoli passa al microscopio i pilastri della medicina di domani, tra batteri, vaccini e AI. E spiega come contrastare la fuga dei cervelli.
Dallo spettro dell’antimicrobico resistenza alle meraviglie dei batteri ‘buoni’, passando per AI e Big Data. Rino Rappuoli, scienziato italiano celebre nel mondo e direttore scientifico di Fondazione Biotecnopolo di Siena, analizza questa fase trasformativa della ricerca medica. “Molti oggi non hanno modo di vedere la malattia e il suo impatto sulle persone. E questo proprio grazie ai vaccini. Diventa dunque più difficile ‘credere’ in questo strumento”, riflette lo scienziato, ‘padre’ di numerosi vaccini innovativi e inventore della “Reverse Vaccinology” (che ha prodotto, fra gli altri, il vaccino per il meningococco B). Rappuoli spiega ai giovani perché oggi “non basta più essere bravi in laboratorio”.
Professore, siamo abituati a temere i batteri, anche per via del fenomeno della resistenza. Lei però qualche tempo fa ha affermato che salveranno il mondo, come mai?
Sì, esatto. Una precisazione importante è che è proprio la biodiversità dei microrganismi a essere indispensabile alla nostra sopravvivenza. Non pensiamo mai, infatti, al numero delle diverse specie, circa un trilione, e al fatto che questi microrganismi sono alla base di molte cose di uso comune, dal vino, al pane, alla birra. Per poi arrivare all’uomo e alla popolazione di “batteri amici” che vive nell’intestino, fino al sistema immunitario che si allena a riconoscere microrganismi “amici e nemici” proprio entrando in contatto con essi. Certo, dobbiamo considerare che una minoranza davvero insidiosa di specie, circa 1.400, è causa di diversi tipi di infezioni e malattie che, in alcuni casi, stanno diventando sempre più difficili da curare poiché gli stessi batteri che ne sono causa sono ormai resistenti agli antibiotici. L’antibiotico resistenza è senz’altro una delle sfide globali che ci troveremo a fronteggiare, anzi la chiamiamo la “pandemia silente” perché è già tra noi. Si pensi che oggi nel mondo sono circa 5 milioni le persone che muoiono ogni anno per un’infezione batterica. Si tratta di un impatto enorme se consideriamo anche le stime che, da qui al 2050, prevedono che il numero di morti possa aumentare fino a 8 milioni.
Come valuta il Nobel per la medicina di quest’anno?
Il Nobel ai due scienziati che hanno scoperto i meccanismi molecolari con cui piccoli Rna regolano i geni è un grande riconoscimento, poiché la scoperta ha permesso di spiegare il funzionamento della regolazione genica, cioè la trascrizione degli stessi in proteine. Tra i Nobel assegnati nel 2024 però mi preme fare una considerazione su quello per la Chimica a Baker, Hassabis e Jumper. Baker, in particolare, è stato un vero pioniere che grazie al suo programma “Rosetta” ha permesso il design computazionale delle proteine. Gli altri due, sebbene non direttamente legati al mondo della chimica, programmando per la risoluzione di alcuni giochi, come il famoso “Go”, hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per prevedere le complesse strutture delle proteine. Negli anni ’80 per fare la struttura di una proteina ci voleva una decina di anni, oggi è possibile in una frazione di secondo. Una vera rivoluzione, data dalla commistione tra la scienza e l’intelligenza artificiale.
Restiamo in tema, come valuta l’impatto dell’AI e dei Big Data?
L’impatto è fortissimo e pervasivo ed è dovuto al fatto che negli ultimi 40-50 anni gli scienziati hanno popolato database con dati proprio sulle strutture delle proteine, che è il principale esempio da fare quando si parla di Big Data. L’arrivo dell’intelligenza artificiale e del machine learning ha permesso non solo di collezionare grandi moli di dati ma anche di interrogarle, consentendo di interpretarle in tempi brevissimi. Dall’altro lato, stiamo assistendo a un fenomeno che ci deve mettere in guardia dall’impiego dell’AI su piccoli gruppi di dati, perché in questo caso potrebbe fallire (lo stiamo vedendo nelle scienze sociali, ad esempio, con modelli predittivi). Il messaggio è che, sebbene si tratti di una innovazione impattante, l’AI è un’arma fortissima che dovremo imparare a usare in modo appropriato.
Professore, lei è stato il padre di molti vaccini, come mai gli italiani mostrano tanto scetticismo su questo strumento di prevenzione?
Lo scetticismo sui vaccini purtroppo si riscontra in tutto il mondo. Mi sento di dire che non siamo ancora abbastanza bravi a educare su questi temi. Anche perché, proprio grazie ai vaccini, molte persone oggi non hanno modo di vedere la malattia e il suo impatto sulle persone, spesso bambini. Diventa dunque più difficile “credere” in questo strumento. Ai miei tempi, quando ero piccolo, c’erano bambini con la poliomielite, magari a scuola, e non era così difficile per i genitori credere all’importanza di poter avere soluzioni mediche per queste malattie. Gli scettici o, addirittura, i no-vax di per sé sono una minoranza, ma si tratta di una minoranza molto rumorosa, che punta a diffondere informazioni sbagliate attraverso piattaforme come i social, che poggiano dunque su meccanismi di viralità (se vogliamo rimanere in tema). Per questo credo si debba insistere sempre di più sull’educazione e sulla corretta informazione.
A suo parere quali sono i vaccini più interessanti allo studio? E quelli di cui ci sarebbe più bisogno?
I vaccini sviluppati ad oggi hanno avuto il ruolo cruciale di eliminare alcune malattie che fino a 100 anni fa uccidevano bambini nei primi anni di vita. Oggi non c’è più mortalità infantile nei Paesi sviluppati e l’aspettativa di vita (anche per altri fattori ambientali) è molto aumentata. Adesso, dunque, ci si sta concentrando molto di più su quei vaccini che permettono di mantenere in buona salute la popolazione anziana, come quello contro l’Herpes zoster, lo Pneumococco o l’influenza. Tra quelli di cui avremmo più bisogno ci sono i vaccini contro batteri resistenti agli antibiotici, ancora non in sviluppo. Consideriamo inoltre la strada che si è aperta in ambito oncologico: i vaccini antitumorali sono stati un sogno per un secolo intero. Oggi, grazie a nuove tecnologie, è possibile mettere a punto dei vaccini che possono avere un impatto sul tumore (in abbinamento con l’immunoterapia) e questa rappresenta una grande svolta.
Qualche mese fa si era detto pronto a lasciare l’Italia se il Biotecnopolo di Siena non fosse partito, a che punto siamo?
Di fatto non me ne sono andato. Sono ancora qui perché sono confidente che il progetto possa partire presto. Il Biotecnopolo è un progetto di grande valore strategico per il nostro Paese ma anche a livello internazionale. Sono confidente di partire presto con un progetto così importante che, attraverso il Centro Nazionale Antipandemico, ci permette di lavorare, grazie a specifiche competenze e approcci, sullo sviluppo di vaccini e anticorpi monoclonali contro patogeni, siano essi virus o batteri.
Una delle sfide dell’Italia è attirare capitali per la scienza, l’altra mantenere e attrarre cervelli. A che punto siamo?
Nelle scorse settimane c’è stata una presentazione al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di uno studio fatto da una serie di scienziati e imprenditori italiani sul tema delle biotecnologie, che ha sottolineato quanto il settore rappresenti un asset strategico per il Paese con grandi potenzialità di crescita. Secondo lo studio lo scorso anno il 50% dei farmaci approvati erano biologici e in prospettiva si stima che si arrivi all’80%. Per questo tipo di crescita sono necessarie entrambe le leve, la capacità di attrarre capitali dall’estero e l’attrazione di talenti, ma è anche fondamentale un grande intervento del settore pubblico. Il biotech è uno di quegli ambiti che diventano sempre più determinanti per la capacità di crescita futura del nostro Paese e non riguarda solo i farmaci, ma anche l’agricoltura. L’impatto che può avere sul frenare l’emergenza climatica è fortissimo.
Come valuta le nuove generazioni di ricercatori? L’Italia saprà ancora lasciare il segno?
I giovani sono sempre stati e continuano ad essere molto bravi ed entusiasti; in particolare in Italia sono sia appassionati, sia ben preparati. La riflessione che dobbiamo fare oggi, rispetto a decenni fa, è che occorre massima attenzione alla preparazione specifica su quelli che chiamiamo lavori del futuro, perché non basta più essere bravi in laboratorio: abbiamo visto l’impatto dell’AI sulle scienze biologiche. Come Paese dobbiamo però creare quelle condizioni favorevoli per essere competitivi anche a livello mondiale. Questo si fa solo dando vita a centri d’eccellenza sul territorio, come si è fatto a Siena, che permettano ai giovani ricercatori italiani di formarsi qui e di poter mettere a disposizione competenze e know-how.