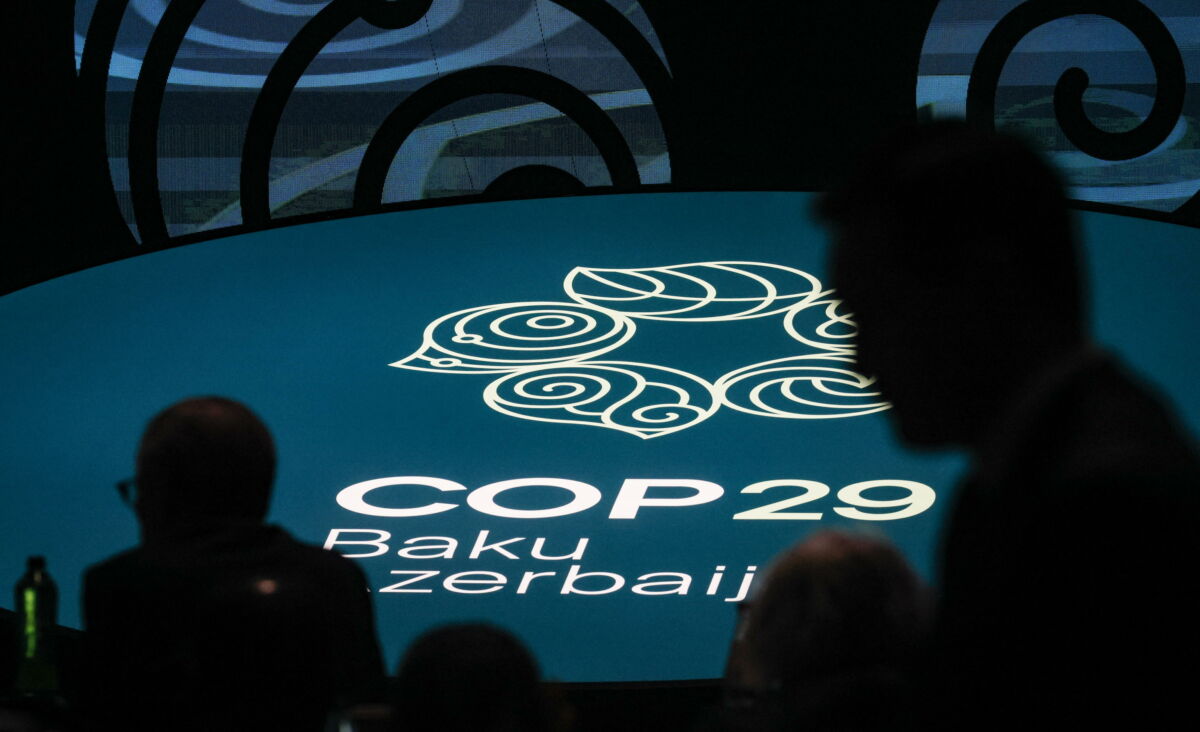Un esordio sconfortante, a voler essere generosi. La Cop29 rischia di essere una tappa di passaggio, un mero esercizio diplomatico zeppo di retorica e privo di risvolti concreti. A Baku molti leader non si fanno vedere, un capodoglio morto compare spiaggiato sul lungomare della città e una Ong ambientalista mette online un sito con il dominio cop29.com e i volti dei magnati del petrolio.
Perché il petrolio conta eccome. L’Azerbaijan è uno dei maggiori produttori mondiali e il ministro azero dell’Ambiente, che presiede la Conferenza sul clima targata Onu, ha lavorato per venticinque anni in Socar, grande compagnia petrolifera statale. In compenso, dalla Georgia lancia strali contro lo “stato autocratico e petrolifero” Greta Thunberg, l’attivista climatica con l’inseparabile kefiah. A Baku non si faranno vedere Joe Biden e Ursula von der Leyen, assenti il cinese Xi e l’indiano Modi, non ci sarà il brasiliano Lula, mancheranno pure Macron e Scholz. Confermata invece la presenza del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.
È una Cop di passaggio, si diceva. Dopo l’impegno sancito a Dubai lo scorso anno nel nome del “transitioning away”, del graduale abbandono dei combustibili fossili, tutti attendono l’appuntamento del prossimo anno, la Cop30 di Belem, in Brasile. Così Baku passa in sordina, con difficili negoziati tra i 197 Paesi membri. Il focus della discussione si può riassumere in una parola: i soldi.
L’edizione appena inaugurata infatti ruota intorno alla cosiddetta “finanza climatica”, con l’obiettivo di rafforzare il fondo da cento miliardi di dollari l’anno che i Paesi industrializzati si sono impegnati a versare in favore dei Paesi vulnerabili. Un aspetto delicato, per esempio, riguarderà il ruolo della Cina: si può considerare ancora un Paese in via di sviluppo o invece è destinata a giocare il ruolo di “contributor”?
Mentre gli africani chiedono addirittura 1,3 trilioni, l’Organizzazione meteorologica mondiale annuncia che il 2024 sarà il primo anno con un aumento della temperatura del pianeta superiore a 1,5°. L’Occidente è chiamato allora ad affrontare un nodo politico: come si può costruire un futuro più sostenibile senza condannarsi al declino?
Con il clima non si mangia, verrebbe da dire. E l’Europa, pur chiamata a scontare tutti i peccati di un continente industrializzato culla del capitalismo, pesa soltanto per il 7 percento delle emissioni globali di Co2. La transizione ambientale sta alimentando un’industria, a partire da eolico e fotovoltaico, ma spesso la parte del leone la fanno i nostri competitor. La Cina è il principale produttore mondiale di pannelli fotovoltaici, grossa parte delle terre rare, litio in testa, si trovano in Oriente e, al di là dei proclami, l’Italia resta un Paese fortemente fossile. Anche l’energia che usiamo per le nostre auto elettriche proviene principalmente dal gas.
Gli Usa, primo esportatore mondiale di gas al mondo, hanno eletto un presidente che ha già annunciato l’obiettivo di aumentare trivellazioni ed estrazione per dare nuovo slancio all’industria nazionale di fonti fossili. Donald Trump intende uscire dall’Accordo di Parigi sul clima, come ha già fatto nel 2017, e la scelta di nominare Lee Zeldin, già avvocato del presidente eletto e riservista dell’Esercito, alla guida dell’agenzia americana incaricata della protezione ambientale segnala la volontà di uno U-turn. L’industria prima di tutto.
L’Europa, e l’Italia, devono capire da che parte andare. Nel caso del nostro Paese, ai costi esorbitanti di un processo di transizione troppo rapido nel tempo e troppo oneroso sul fronte degli standard imposti si aggiunge la scelta di rinunciare alla partita del nucleare. La conseguenza è che in Francia si pagano circa 40 euro per megawattora, da noi oltre 100. Anche di questo dovranno tener conto i Grandi del mondo: salvare la competitività delle nostre aziende è un’esigenza primaria.