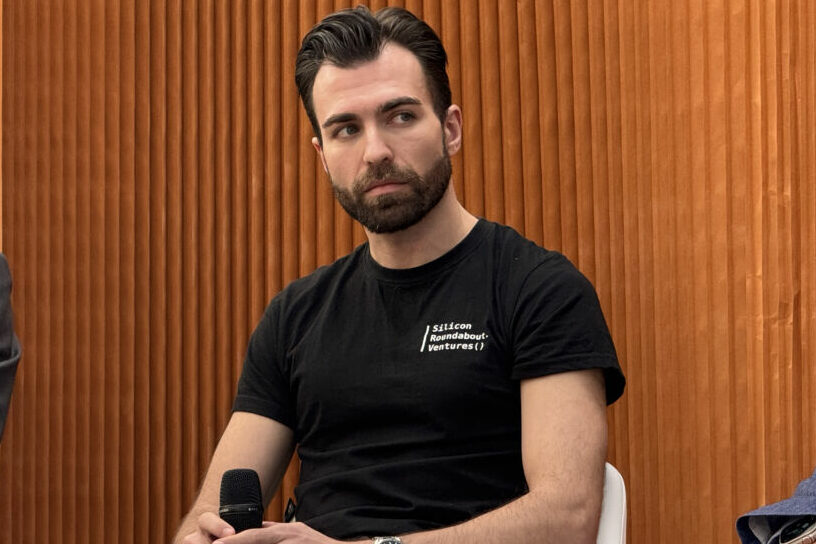Ricordate Don Camillo e Peppone? Avete presente i classici screzi verbali e le simpatiche trame di Fernandel alla presa con i comizi di Gino Cervi? Tempi passati, si dirà. Oggi è sempre più difficile riunire persone e chiamarle ad assistere ai classici incontri elettorali. E se la discussione interpersonale rimane sempre una strategia basilare per attrarre voti, al fianco degli incontri che in qualche modo pongono a diretto confronto i candidati con l’elettorato potenziale, si sta sempre più facendo strada il mondo dei social. Un tema caldo, nel giorno della vittoria di Donald Trump alle presidenziali degli Stati Uniti.
Così tematiche, esperienze, pareri personali diventano una sorta di veicolo per indirizzare le scelte. Insomma, esiste un mondo virtuale che in qualche modo si accompagna a quello reale, delle strette di mano e degli abbracci, con un impatto potenzialmente molto importante sull’espressione del proprio parere in chiave politica.
Ma se è vero che sempre di più la rapidità del testo, l’impatto di un video, il valore di un’immagine possono in qualche modo influire sul nostro pensiero, non ci sono dubbi che le regole di questo mondo parallelo a portata di smartphone o device vari vanno comprese. E magari verificate. Per tenerne conto. Perché nella “bolla” virtuale di X e Facebook, a prescindere dai post, occorre forse adattarsi a regole diverse.
Il gioco della proposta politica, sulle piattaforme, è insomma vario. E spesso può presentare specifiche problematiche che vanno oltre le convinzioni di ognuno. Tanto che magari siamo portati a non commentare quanto ci interessa, limitandoci ad un generico like. Mentre probabilmente tendiamo a scatenarci quando qualcosa va contro il nostro pensiero.
E così ci troviamo ad interagire più facilmente quando ci troviamo di fronte, sempre virtualmente, a contenuti contrari alle nostre opinioni. E’ una chiave di lettura diversa. Più che portarci a discutere ed argomentare la bontà delle nostre scelte, insomma, sui social siamo maggiormente pronti a contrattaccare chi si trova su posizioni diverse. Con un grande vantaggio comunicativo per le controideologie, piuttosto che per quanto ci vede sulla stessa lunghezza d’onda.
Insomma: a guidarci sarebbe più l’indignazione nei confronti di quello in cui non ci ritroviamo. E sarebbe per questo che i contenuti politicamente più pesanti e divisivi raccolgono in genere un maggior numero di interazioni.
A spiegare questo “effetto di confronto”, che ci guida a commentare o a proporre espressioni che sono spesso negative rispetto a quanto viene proposto, è una ricerca degli esperti dell’Università Tulane, guidati da Daniel Mochon, pubblicata su Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Negli Usa sono stati osservati i comportamenti di oltre mezzo milione di persone in risposta a post politici su Facebook e Twitter, per osservare come gli utenti rispondevano in base alle loro opinioni. Ed è emerso chiaramente come si sia molto più propensi a commentare o reagire a post che contraddicono le convinzioni personali, specie se si vanno a toccare valori fondamentali.
In una nota dell’ateneo, Mochon spiega che il meccanismo alla fine fa il gioco dalle piattaforme, quali esse siano. Più che degli utenti. Perché rende partecipe un maggior numero di persone. Così aumentano le interazioni, si stimola il coinvolgimento. E per questo obiettivo si punta più sulla rabbia, che sull’effettiva condivisione di valori. “Le piattaforme traggono vantaggio dal mantenere gli utenti attivi, indipendentemente dal fatto che l’interazione sia positiva o negativa” è il parere dell’esperto.
Il pianeta social, insomma, tenderebbe a privilegiare i messaggi più estremi. Rendono di più sui dispositivi, sotto forma di like o dislike. In politica, punta sull’ira e sul risentimento, alimentando un circolo vizioso difficile da spezzare. E noi ne facciamo parte.
Se si parla di altri argomenti, ad esempio moda o sport, a farci interagire è il reale interesse. Sui social rischiamo di trasformarci. E di spingerci ad esprimere indignazione più che concordanza. Cosa fare? Forse tutti, ben oltre le opinioni, dovremmo chiedere un impegno che ci aiuti a recuperare il piacere del confronto, per non affossarci a rispondere d’impeto a contenuti controideologici rispetto al nostro pensiero.