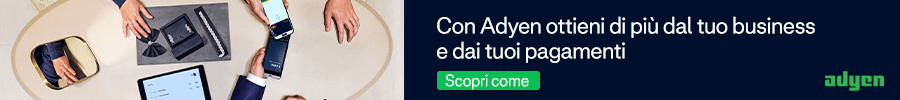Come un incendio nell’addome, a volte fitte violente come coltellate, che lasciano senza fiato. Costringendo a rinunciare a giorni di scuola o di lavoro. Sono i sintomi dell’endometriosi, malattia dolorosa che impatta anche sulla fertilità e che solo in Italia – ricorda l’Istituto superiore di sanità – colpisce più di 1.800.000 donne in età riproduttiva, ma che ancora troppo spesso viene diagnosticata in ritardo. Parliamo di sette anni, in media.
E questo anche per via dell’atteggiamento, molto femminile, che porta a sopportare il dolore. Ebbene, in occasione della Giornata dedicata all’endometriosi, cerchiamo di conoscere meglio questa patologia. Legata, secondo alcune ricerche, all’inquinamento ambientale. Anche per rompere il muro del silenzio e spingere le giovani pazienti a chiedere aiuto.
Che cos’è l’endometriosi
Come ricorda l’Iss l’endometriosi è dovuta alla presenza di endometrio (mucosa che ricopre internamente l’utero) all’esterno dell’utero. Con un notevole impatto sulla qualità della vita e non solo: si stima che tra il 30-40% delle donne che soffrono di endometriosi possa riscontrare problemi di fertilità o subfertilità.
Nel 2023 il Parlamento italiano ha approvato una legge per il riconoscimento dell’endometriosi come malattia cronica invalidante. E non a caso: lo è tanto da portare spesso le pazienti in ospedale.
Negli ultimi 10 anni sono stati registrati più di 113.000 ricoveri per endometriosi, con un tasso di incidenza pari a 0.82 casi per 1000 donne in età fertile (15-50 anni) e un trend in calo tra il 2013 e il 2019. “La diminuzione è ancora più marcata nell’anno 2020, presumibilmente per un ridotto accesso ai servizi sanitari dovuto alla pandemia”, rilevano gli esperti dell’Iss. Dal 2021 l’incidenza torna ai livelli del 2019 con in media circa 9.300 nuovi casi l’anno e un tasso stabile nel triennio 2021-2023 pari a 0.76 casi per mille.
L’incidenza della malattia tende ad aumentare con l’età e raggiunge il picco fra 31 e 35 anni (0,12% a livello nazionale). Inoltre il monitoraggio rileva tassi leggermente più alti di endometriosi nella provincia autonoma di Bolzano, in Veneto e Sardegna, con una diagnosi in più di una donna in età fertile su mille.
Il ritardo della diagnosi e i giorni di scuola persi
Come dicevamo, le statistiche indicano che il tempo medio per una diagnosi corretta è di circa 7 anni, anche per via della natura poco specifica dei sintomi. “Il 64% delle ragazze con dolore pelvico associato al ciclo mestruale ha già l’endometriosi, ma non lo sa e convive con la sofferenza di questa patologia. Un atteggiamento di rassegnazione, supportato da una società che tende a minimizzare le mestruazioni dolorose, anche quando diventano un disturbo debilitante che interferisce con la normale vita quotidiana, fino a interrompere l’attività scolastica, in media per 19 giorni l’anno“, dicono dall’Irccs Negrar.
A segnalarlo una review dell’University College di Londra e dell’Università di Birmingham pubblicata sul Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology. I ricercatori, esaminando 19 studi condotti tra il 2011 e il 2019, su un totale di 1.243 ragazze, hanno messo in luce l’entità del problema.
“Soffrire non è normale: ribellatevi alle vostre mamme e nonne quando vi dicono di sopportare il dolore. E anche al medico, se vi dice che è tutto a posto ma voi continuate a stare male. La rassegnazione alla sofferenza allunga di tre volte il ritardo nella diagnosi”, insiste Marcello Ceccaroni, direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Irccs Negrar, che ha messo a punto una tecnica chirurgica mini-invasiva in grado di ridurre dal 37 al 4% le disfunzioni pelviche.
“La diagnosi tardiva è il nemico principale delle donne con endometriosi: più della stessa malattia. Una delle ragioni principali è proprio la rassegnazione con cui molte giovani vivono il dolore associato alla patologia”, dice Ceccaroni.
Il dolore pelvico
Il dolore da endometriosi si manifesta durante e tra i cicli mestruali, nei rapporti sessuali, nell’evacuazione e spesso si associa a disturbi gastroenterici. Le variazioni ormonali che si verificano nel ciclo ovarico “determinano fisiologicamente fenomeni infiammatori e conseguente dolore pelvico ciclico, noto come dismenorrea primaria, trattato efficacemente con i comuni analgesici”, rileva Flaminia Coluzzi professore di Anestesiologia e Terapia del Dolore presso l’Università Sapienza di Roma.
“Tuttavia a livello pelvico sono presenti anche cellule della nostra immunità innata, note come mastociti, che fisiologicamente proteggono il nostro sistema nervoso: se iperattivate possono determinare fenomeni patologici di sensibilizzazione centrale, con la conseguenza che i segnali provenienti dalle strutture pelviche vengono amplificati. Questo fenomeno, noto come neuroinfiammazione, è alla base dell’evoluzione verso il dolore pelvico cronico”, afferma la Coluzzi, autrice di una recente pubblicazione su Expert Opinion on Pharmacotherapy.
Il messaggio è chiaro: “In età adolescenziale il dolore pelvico non va sottovalutato, soprattutto quando compromette le normali attività quotidiane. Controllare tempestivamente la neuroinfiammazione consente di ridurre il rischio di dolore pelvico cronico in età adulta. Questo è possibile utilizzando molecole note come ALIAmidi, che riportano i livelli di neuroinfiammazione al ruolo fisiologico protettivo per l’organismo”, ribadisce Coluzzi.
Come intervenire per spegnere l’endometriosi
La prima soluzione per arrestare l’endometriosi è farmacologica. Ma quando le terapie mediche falliscono e la malattia è avanzata, il bisturi diventa una scelta obbligata. “La tecnica messa a punto al Negrar, che si chiama nerve-sparing – precisa Ceccaroni, ideatore del nuovo approccio notocome “Negrar Method” – consente la stessa radicalità chirurgica rispettando il maggior numero di fibre nervose superstiti, che spesso vengono danneggiate durante l’intervento. Si riduce così il rischio di disfunzioni post-operatorie”.
L’effetto dell’inquinamento
Ma quali sono le cause di questa malattia femminile così impattante? Alcuni approfondimenti preliminari effettuati dall’Iss mostrano che il rischio potrebbe essere associato al fatto di vivere in aree contaminate da inquinanti persistenti che si bio-accumulano, come i policlorobifenili, le diossine, il piombo e il cadmio.
Lo studio suggerisce l’opportunità di attivare sistemi di sorveglianza epidemiologica integrati al monitoraggio ambientale nelle aree fortemente contaminate. A tutela della salute femminile e della fertilità.