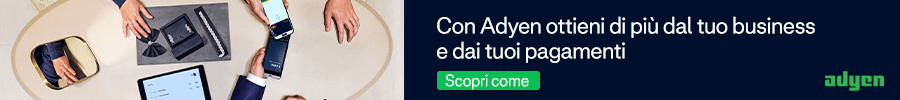Il futuro delle malattie neurodegenerative è racchiuso in tre parole: medicina di precisione. Declinata magari attraverso cellule staminali o terapie target, studiate in base alle caratteristiche del singolo paziente. Farmaci viventi, sempre più intelligenti e combinati, dunque. Ma anche tanta prevenzione, “un dovere” per la salute del nostro cervello, che ci rende protagonisti attraverso le scelte di tutti i giorni.
Ne è convinto Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), neurofarmacologo affascinato fin da giovanissimo dai meccanismi alla base della plasticità cerebrale. Nato a Londra, laureato in Medicina e specializzato in Psichiatria, Nisticò guarda alle sfide per la salute del cervello e per la ‘sua’ Aifa, tornando spesso sul legame tra geni e ambiente.
E lo fa da ‘figlio d’arte’: suo padre Giuseppe – detto Pino – è un farmacologo e politico di Forza Italia, già presidente della Regione Calabria. Così, se la passione per il mondo dei farmaci e l’empatia sembrano scritte nel Dna del presidente, nelle sue abitudini con i medicinali a fare la differenza è l’ambiente: “Cerco di ridurne al minimo l’impiego, ma li utilizzo, anche gli antibiotici. Ho tre figli piccoli a casa – confida – e ci ammaliamo tutti a rotazione”.
Quella italiana è una popolazione che invecchia, quale sarà nei prossimi anni l’impatto delle malattie neurodegenerative? È un tema che la preoccupa?
È vero per l’Italia, ma tutti i Paesi avanzati hanno una popolazione che invecchia. Ho avuto la fortuna di lavorare anche col Premio Nobel Rita Levi-Montalcini che diceva sempre: “Non bisogna solo aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni”. E questo è importante anche per la tenuta sociale.
Ho tre bambini piccoli e, onestamente, i nonni ci danno una grande mano: avere anziani performanti oggi è importante per la società nel suo insieme. Ebbene sì, le malattie neurodegenerative mi preoccupano: l’età è il primo fattore di rischio. La maggior parte di queste patologie è sporadica, una parola che non tutti conoscono.
Vuol dire che non c’è solo un gene difettoso che porta alla malattia, ma un insieme di cause: genetiche, ambientali e poi entrano in gioco i meccanismi epigenetici, che fungono da cerniera tra le altre due.
Le malattie neurodegenerative saranno sempre più impattanti sulla società, per via dell’invecchiamento della popolazione. Dobbiamo trovare il modo per prevenirle o, quantomeno, rallentarne il decorso. E non c’è solo il farmaco: c’è da fare soprattutto prevenzione.
Fino a pochi anni fa le terapie disponibili erano molto limitate. Ora dalla ricerca stanno arrivando trattamenti che mostrano una certa efficacia nelle fasi iniziali della malattia. Quali sono a suo parere le soluzioni più interessanti nel caso dell’Alzheimer?
L’Alzheimer è una malattia complessa con cause genetiche, ambientali e meccanismi ancora poco conosciuti. L’ipotesi che spiegava l’Alzheimer negli anni ’90 era la teoria della beta amiloide, una proteina che accumulandosi nel cervello può creare infiammazione, portando alla neurodegenerazione.
Allora tutte le ricerche si sono focalizzate su questa proteina. Diversi anticorpi monoclonali sono stati studiati nella ricerca sperimentale e clinica e uno di questi è stato approvato recentemente in Europa. In America ne sono stati autorizzati tre: farmaci simili, che bloccano questa proteina, ma che comunque hanno forti limiti. Perché rimuovere la beta amiloide non necessariamente si traduce in un impatto clinico e funzionale per il paziente.
Possiamo dire che questi sono farmaci che rallenteranno il decorso della patologia, ma lo faranno in maniera transitoria: l’efficacia a lungo termine non è ancora molto chiara. Io ritengo che, essendo una patologia così complessa, occorre aggredire l’Alzheimer da tanti punti di vista, con terapie cosiddette in combinazione.
Quindi il futuro sarà probabilmente basato da un lato sulla prevenzione e poi, nel momento in cui il biomarcatore ci permetterà di fare diagnosi e di capire la prognosi, saranno importanti le terapie target, che colpiscono il bersaglio più giusto per ciascun paziente. Con un approccio in combinazione che punta alla medicina di precisione.
Da Minority Report a Limitless, molti film hanno indagato sul potere della mente. A suo parere quali meccanismi biologici saranno al centro delle ricerche sulle malattie del cervello?
Questa è una domanda difficile. Da sempre studio i meccanismi della plasticità sinaptica, cioè come il nostro cervello riesce ad adattarsi all’ambiente circostante, ad esempio ad acquisire informazioni e a trasformarle in memoria.
Un tema complesso dal punto di vista molecolare, perché la sede della memoria sono le sinapsi, entità che comunicano tra loro attraverso i neurotrasmettitori e che poi in qualche modo fanno sì che il nostro cervello funzioni. La comprensione dei meccanismi molecolari alla base della plasticità sinaptica potrebbe rivelare nuove sorprese e nuovi target farmacologici.
L’altro aspetto interessante da chiarire è legato all’epigenetica. Ho parlato di una cerniera tra ambiente e geni. Pensiamo allora al Dna come a una fisarmonica che si apre e si chiude: ci sono meccanismi che possono impattare sull’espressione genica. I geni non si modificano, ma è possibile alterarne l’espressione con una serie di approcci farmacologici.
La terza area interessante, anche se ancora siamo in una fase embrionale, è quella delle cellule staminali (cellule ‘bambine’ in grado di auto rinnovarsi e di trasformarsi, dando origine a diversi tipi cellulari, ndr).
Le cellule nervose degenerano e non si replicano, quindi puoi solo rallentare la degenerazione. Ma con le staminali in teoria potremmo rimpiazzare quelle danneggiate con cellule nuove. Certo è molto difficile da fare.
Penso che sarà la sfida dei prossimi anni. Nella malattia di Parkinson sono state condotte sperimentazioni cliniche su pochi pazienti con trapianto autologo di staminali ingegnerizzate, ma i dati sono ancora scarsi e veramente iniziali.
Passiamo all’Aifa, la sfida è doppia: assicurare tempi congrui sul fronte dell’accesso dei pazienti alle novità della ricerca, ma anche la sostenibilità del sistema. Qual è la sua strategia?
L’innovazione costa e costerà sempre di più, non solo in Italia, ma in Europa e nel resto del mondo. Noi dobbiamo far sì che raggiunga il paziente. Come? Secondo me considerando anche dei percorsi individualizzati: dobbiamo esser certi che un paziente abbia le caratteristiche giuste per rispondere a una terapia.
La corretta selezione dei pazienti è il primo fattore per raggiungere l’obiettivo. Poi c’è il tema del costo delle terapie, attenzione: non ho detto prezzo. Cerchiamo di ragionare insieme su quale sia l’impatto sulla vita del paziente e il risparmio per la società in termini ad esempio di ricoveri, produttività, tasse.
Insomma, magari una terapia ha un costo elevato, ma se funziona alla fine potrebbe tradursi in un risparmio. Gli studi clinici sono spesso molto limitati, nella vita reale i risultati dei farmaci possono essere differenti e oggi non possiamo pagare tutto subito, soprattutto nel caso delle terapie one shot che, con una sola somministrazione, possono cambiare il decorso della vita di un paziente.
Dobbiamo ragionare insieme sui dati, vedere se e come il paziente risponde e insieme definire così il valore di quel farmaco, sulla base dei dati e dei risultati. Su questo abbiamo avviato un dialogo con le imprese e con Farmindustria (l’associazione delle imprese farmaceutiche, ndr).
Tornando al cervello: si sente dire in giro che usiamo solo il 10% del suo potenziale, è vero o si tratta di un falso mito?
È un falso mito (sorride, ndr). Ma è vero che il cervello è tutto utile e ha una capacità straordinaria: la plasticità. Lo vediamo anche nel Parkinson e nell’Alzheimer, malattie i cui sintomi insorgono quando già una grande parte del cervello è danneggiata.
Quindi le cellule sane riescono a vicariare anche le funzioni di quelle che degenerano. Insomma, il cervello è potente e ha una grande capacità di compensazione.
Con gli anni, stando alle ricerche, il nostro cervello tende a rimpicciolire. Cosa è possibile fare sul fronte della prevenzione?
Noi siamo fatti di genetica e ambiente: oggi sappiamo che dieta, stile di vita, attività intellettuale sono fattori che possono in qualche modo proteggere il soggetto da queste patologie o rallentarne l’eventuale insorgenza.
Bisogna investire sulle politiche della prevenzione già dalle scuole: perché proprio come la tutela della salute è un diritto, la prevenzione è un dovere affinché questo diritto alla salute venga protetto, soprattutto in una popolazione che invecchia.
Quello che voglio dire è che non avremo risorse infinite: dobbiamo puntare moltissimo sulla prevenzione, e a dircelo sono anche gli esempi dei centenari. Dunque attività fisica, esercizi per la mente, dieta e stile di vita per imparare a invecchiare in salute.
Presidente, da aprile scorso lei è alla guida dell’Agenzia italiana del farmaco. Può tracciare un bilancio della sua esperienza e illustrarci le sue priorità per il 2025?
La mia è un’esperienza positiva. Sono circondato da persone molto, molto in gamba che mi arricchiscono ogni giorno.
Le sfide sono quella di rendere l’innovazione sostenibile, lavorando insieme alle istituzioni, alle Regioni, ma anche nel contesto internazionale per una valorizzazione dell’Agenzia che deve essere vista come una risorsa strategica per il Paese.
Sto lavorando anche con le associazioni dei pazienti: non dobbiamo essere isolati in Aifa, ma condividere insieme percorsi e idee e arrivare alla fine al paziente, perché cercare di proteggere e salvaguardare i deboli è la cosa più importante.
Una curiosità: quando era bambino cosa avrebbe voluto fare da grande?
Mio papà, medico e farmacologo, ha fatto anche un’esperienza politica ed è stato per me certamente un modello. Noi viviamo anche di stimoli ambientali, e mi ha sempre affascinato il fatto che ciascuno di noi può mettersi al servizio degli altri.
Per me mio padre è stato un modello di ispirazione, ma forse ci sono anche aspetti genetici: io sono molto simile a lui, anche caratterialmente. Probabilmente sarà entrato in gioco un mix tra genetica e ambiente (sorride, ndr).
Devo dire poi che da bambino ho sempre cercato l’ascolto e l’empatia, che ho voluto in qualche modo mettere a frutto con i miei studi. Aspetti che mi sono serviti anche in Aifa, un’agenzia affascinante ma complessa.
Più volte ha sottolineato l’importanza di assicurare talenti e competenze all’Agenzia: siete in cerca di particolari professionalità?
Certo, da un lato è opportuno favorire un ricambio generazionale. Ci sono persone molto esperte che si sono formate qui e hanno delle professionalità uniche, costruite sul campo. Però è anche vero che bisogna pensare al futuro, quindi mi piacerebbe che durante questo mandato ci sia la possibilità di selezionare quelli che saranno i prossimi protagonisti del sistema dell’Agenzia.
Anche perché viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti. L’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti, ma pochi sono davvero competenti. Penso che noi dobbiamo dotare l’agenzia di queste expertise, molto importanti anche per velocizzare i processi decisionali.
Ma vorrei implementare anche tutti i clinici, perché nelle valutazioni regolatorie spesso manca la componente di chi ha avuto a che fare con i pazienti. Quindi clinici, esperti di intelligenza artificiale e anche statistici: la nuova Aifa si deve dotare di queste professionalità.
Un suo celebre collega, il farmacologo Silvio Garattini, dice di usare pochissimo i farmaci. Quale approccio ha lei nella vita di tutti i giorni, in famiglia?
La teoria è quella del professor Garattini, frutto anche di una genetica favorevole e di uno stile di vita sano. Io nella vita di tutti i giorni cerco di ridurre al minimo l’uso di questi farmaci, ma li utilizzo, anche gli antibiotici.
Come dicevo a casa, con tre bambini piccoli, ci ammaliamo tutti a rotazione. Insomma, quando sono necessari i farmaci vanno utilizzati, seguendo le indicazioni del medico.
Torniamo alla salute del cervello: può condividere tre suggerimenti per invecchiare in salute?
Il primo consiglio è essere curiosi della vita: bisogna stimolare il cervello. Come? Banalmente andando al cinema, a teatro, viaggiando, leggendo. Ce lo dice anche la letteratura scientifica: più stimoli il cervello, più è in grado di accumulare la riserva cognitiva che aiuta a rallentare il declino legato all’età.
Poi bisogna avere un approccio olistico: quando parliamo di cervello si chiama in causa l’organismo nel suo insieme. Bisogna tornare alla visione di una volta e smettere di ragionare organo per organo.
E ancora: fare una vita sana, che vuol dire mangiare bene, fare esercizio fisico.
Tutto questo è stato dimostrato dalla letteratura, che ne ha chiarito i meccanismi molecolari. Quindi avere un cervello curioso, mangiare bene, fare esercizio fisico, viaggiare, avere relazioni sociali: questi sono per me gli ingredienti alla base della ricetta per invecchiare in salute.
Robert Nisticò
Nato a Londra e cresciuto in Italia, ha una laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Psichiatria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Professore ordinario di Farmacologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, è in aspettativa per svolgere le funzioni di presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, che guida da aprile 2024. Ha collaborato con l’European Medicines Agency (Ema), ed è autore di oltre 180 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
Ha ottenuto due ‘Marie Curie Fellowship’ ed è stato Honorary Lecturer presso la School of Pharmacy dell’Università di Nottingham (UK).