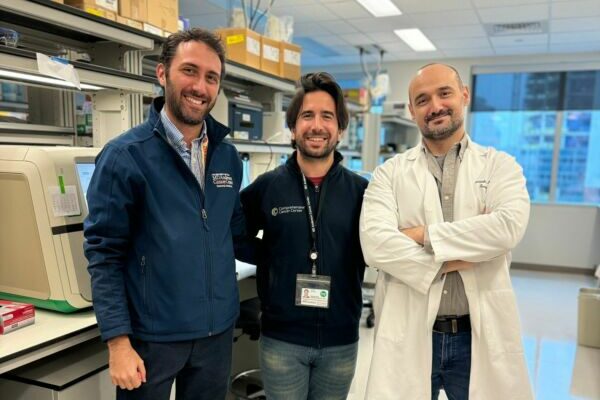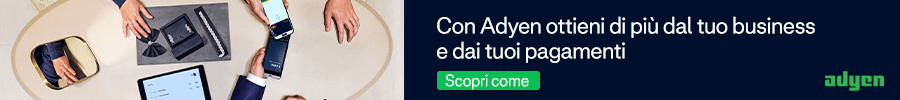Perchè alcuni tumori, come quello al pancreas, sono così insidiosi? A mettere in luce una sorta di ‘interruttore’ capace di rendere le cellule del tumore più cattive è una ricerca pubblicata su Nature da giovani ricercatori italiani del MD Anderson Cancer Center (Usa), provenienti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dai loro maestri Giampaolo Tortora e Alessandro Sgambato. Uno studio che ci aiuta a comprendere meglio meccanismi chiave del tumore, che appare sempre più una malattia ‘trasformista’.
Ma la scoperta apre anche la strada all’individuazione di biomarcatori in grado di intercettare la plasticità della cellula tumorale, nell’ottica di un approccio sempre più mirato ed efficace. Insomma, la scoperta apre a nuove speranze in particolare nel caso del tumore del pancreas, come vedremo a breve.
I giovani cervelli
Insieme al guru del tumore al pancreas e al vicepreside della Facoltà di Medicina della Cattolica, a firmare la ricerca sono anche Luigi Perelli e Giannicola Genovese (rispettivamente primo autore e corresponding author) che provengono dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica; tra gli autori dello studio c’è anche Enrico Gurreri, specializzatosi in Oncologia all’Università Cattolica lo scorso novembre, che ha fatto la sua tesi di specializzazione proprio all’MD Anderson Cancer Center (tutti e tre nella foto principale).
Il caos dentro una cellula
Le cellule tumorali sono eterogenee per natura, ma in alcuni tumori come quello del pancreas alcune di queste caratteristiche risultano più ‘tipiche’ delle cellule mesenchimali, che non di quelle epiteliali. Gli esperti definiscono questa ‘trasformazione’ epitelial mesenchimal transition (EMT), un meccanismo che rende le cellule più aggressive, permettendo loro di sfuggire a vari tipi di controllo.
Quando all’interno di un adenocarcinoma (tumore che origina da un epitelio) è presente una componente mesenchimale “l’atteggiamento di quella neoplasia è più aggressivo”, dice Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia Medica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Comprehensive Cancer Center di Fondazione Policlinico Gemelli. Ma c’è di più: la transizione da cellula epiteliale a cellula mesenchimale “comporta il caos all’interno del Dna della cellula. Si verificano cioè alterazioni macroscopiche che diventano talmente numerose da provocare la frammentazione dei cromosomi. Questi ‘pezzi’ rotti inoltre si ricompongono, si riarrangiano tra loro a caso, in maniera disordinata, creando ulteriori disastri. Questo studio ha evidenziato che l’acquisizione di queste caratteristiche ‘mesenchimali’ porta a una maggior aggressività delle cellule tumorali”.
“Questa scoperta rappresenta l’inversione del paradigma secondo cui ‘il genotipo determina il fenotipo’, cioè che la cellula appare e si comporta in un certo modo perché il suo Dna le ha detto di comportarsi così. In questo caso è il fenotipo a condizionare il genotipo”, aggiunge lo specialista.
L’individuazione futura di alcuni biomarcatori che identificano e intercettano questa plasticità della cellula tumorale, permetterebbe di “intervenire in modo tempestivo, ad esempio modificando la terapia”, precisa Tortora.

Il caso del tumore del pancreas
Stando al volume “I numeri del cancro in Italia 2024″, nel nostro Paese nel 2022 sono stati stimati 35.700 decessi per cancro del polmone, 24.200 per il colon-retto, 15.500 per la mammella e 14.900 per tumore al pancreas. Una sfida importante, dunque, di fronte alla quale la ricerca non si ferma.
Se il meccanismo messo in luce dai ricercatori è tipico di diversi tumori, risulta amplificato proprio in quello del pancreas. Che potrebbe diventare dunque un paradigma per capire gli altri. “Quello che stiamo imparando quasi sicuramente avrà delle ricadute su tanti altri tumori in cui la EMT è una modalità acquisita dal tumore per sfuggire al controllo e alle terapie”, prevede Tortora.
Questi meccanismi sono anche alla base della metastatizzazione e della formazione di metastasi da metastasi, cioè di metastasi che diventano trampolino di lancio per altre metastasi. Più il tumore si adatta ed è ‘plastico’, più è in grado di infiltrare, di invadere, di acquisire resistenza al trattamento. “Questi meccanismi – dice ancora Tortora – potrebbero un giorno diventare target terapeutici o aiutarci nella diagnosi e nel monitoraggio della risposta alla terapia se riusciremo ad intercettare le sostanze che favoriscono questi adattamenti, magari con l’aiuto dell’intelligenza artificiale”.
Questo lavoro “è molto significativo e ci offre l’opportunità di guardare con occhi nuovi a una patologia molto aggressiva qual è il cancro del pancreas”, interviene Alessandro Sgambato, vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ordinario di Patologia generale e Direttore della Facility di Multiplex Imaging Profiling di Fondazione Policlinico Gemelli. Inoltre “è stato ideato e portato a termine con la collaborazione di altri ricercatori, dai dottori Perelli e Genovese che provengono entrambi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e hanno iniziato il loro percorso di ricerca entrambi nel mio laboratorio. Tra gli autori dello studio c’è anche il dottor Gurreri che ha svolto la sua tesi di laurea nel mio laboratorio e successivamente si è specializzato in Oncologia lo scorso novembre sotto la supervisione del professor Tortora, svolgendo parte del suo lavoro di tesi proprio all’MD Anderson Cancer Center”.