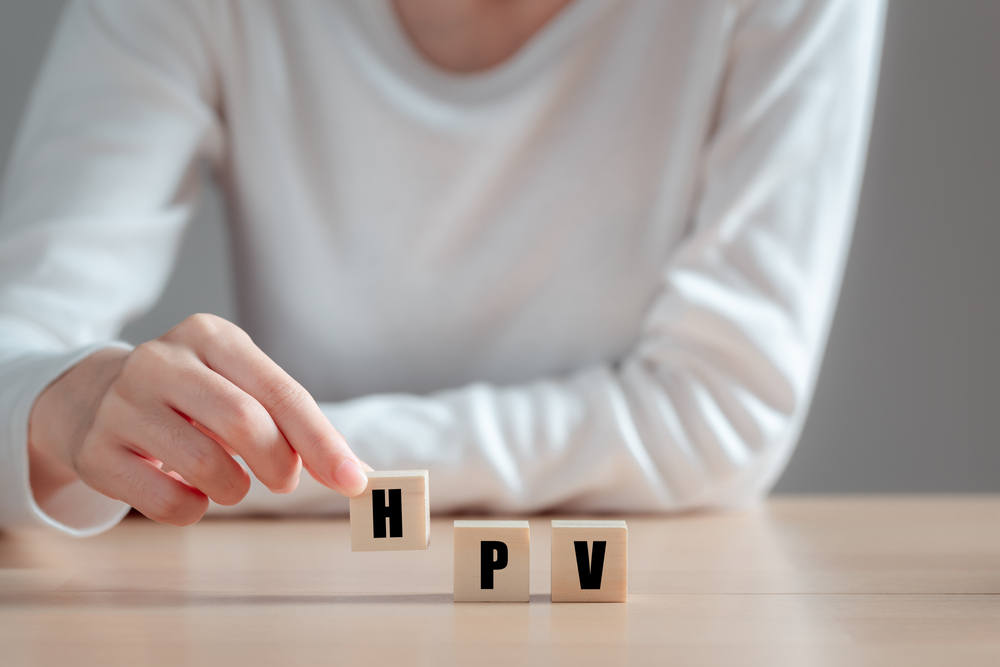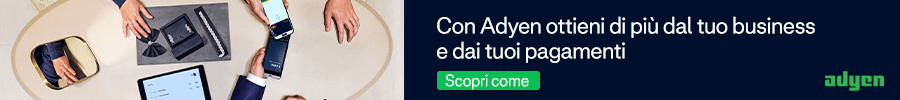L’Italia potrebbe essere il primo Paese europeo a lanciare una strategia di eliminazione del tumore della cervice uterina e gli altri tumori Hpv correlati, ponendosi obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale entro un traguardo temporale certo.
Ne sono convinte le associazioni promotrici del Manifesto per l’eliminazione dei tumori correlati al papillomavirus, che però chiedono alle Istituzioni un’azione mirata e tempi definiti per arrivare all’eliminazione di questi tumori.
Il tutto grazie anche all’approvazione di un Piano straordinario di recupero delle vaccinazioni anti-Hpv e dello screening cervicale rinviati ‘per Covid’.
Un po’ di storia
Nel marzo 2020, un gruppo di Associazioni – Consiglio Nazionale Giovani, Cittadinanzattiva, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Fondazione IncontraDonna, Fondazione Umberto Veronesi, Think Young – ha deciso si sintetizzare le criticità emerse nella lotta ai tumori correlati all’Hpv e amplificate dalle pandemia contro Covid-19.
Un lavoro che culmina nel Manifesto redatto per lanciare un appello alle Istituzioni e alla società civile affinché siano potenziate le attività di prevenzione primaria e secondaria, uniche vere armi contro i tumori causati dal Papillomavirus. Successivamente, anche l’Alleanza Contro il Tumore Ovarico Italia e la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori hanno firmato il Manifesto per portare avanti questa importante battaglia di sanità pubblica e altre realtà hanno aderito, come LOTO OdV, aBRCAdabra e ancora Associazione Italiana di Oncologia Medica, Europa Donna, Federazione Italiana Medici Pediatri, Fondazione PRO, Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e la Società Italiana di Pediatria.
Un virus insidioso
Il Papillomavirus è un virus a prevalente trasmissione sessuale, classificato come secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo. L’infezione da papillomavirus è la più frequente sessualmente trasmessa (circa l’80% della popolazione sessualmente attiva la contrae almeno una volta nel corso della vita), e può causare lesioni benigne, come verruche cutanee e condilomi genitali, lesioni pre-invasive (displasie) o lesioni invasive, quali i tumori della cervice uterina (di cui il Papillomavirus è responsabile nel 97% dei casi) ma anche dell’ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo (in particolare orofaringe).
La comunità scientifica internazionale e le autorità sanitarie di tutto il mondo sono concordi nel definire la prevenzione come carta vincente per la battaglia contro i cancri da Hpv. In che modo? Grazie alla prevenzione primaria tramite la vaccinazione anti-Hpv e alla prevenzione secondaria tramite i test per lo screening per il tumore del collo dell’utero, con la possibilità di curarli efficacemente se identificati tempestivamente.
I numeri
Il vaccino esiste da tempo, ma l’Hpv continua a essere una minaccia concreta di sanità pubblica: ogni anno in Europa, a oltre 66.000 donne viene diagnosticato il cancro cervicale e più di 30.000 ne muoiono. In Italia quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni dell’Hpv, di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per questa neoplasia è stabile intorno al 68%, dato che è troppo basso considerando che si tratta di una patologia prevenibile attraverso la vaccinazione.
La roadmap
Il 17 novembre 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una strategia per eliminare il cancro cervicale causato dal Papillomavirus attraverso il raggiungimento entro il 2030 dei seguenti obiettivi: prevenzione primaria (90% di ragazze vaccinate con ciclo completo entro i 15 anni di età), prevenzione secondaria (70% delle donne sottoposte a screening utilizzando un test ad alta performance),
trattamento (90% delle donne identificate con malattia cervicale trattate e con accesso ad un adeguato follow-up).
Per aiutare gli Stati membri nell’implementazione delle loro strategie nazionali, l’Oms ha redatto una roadmap per il periodo 2022-2030, mirata ad accelerare l’eliminazione del cancro alla cervice uterina nel continente europeo.
Cosa succede all’estero
Alcuni Stati hanno già adottato specifici programmi di prevenzione. Ad esempio, l’Australia punta a diventare a tutti gli effetti il primo Paese a eliminare il tumore cervicale entro il 2035, abbassando il tasso di incidenza a meno di 4 casi su 100mila. Seguiranno il Canada e l’Inghilterra che prevedono di eliminarlo per il 2040.
L’Italia si è dotata di un proprio Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 che insiste, tra i diversi obiettivi, sulla necessità di incentivare l’offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
Inoltre nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025 si introduce per la prima volta come obiettivo esplicito il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie Hpv correlate e si mantiene fermo il target già precedentemente fissato del 95% di copertura per quanto riguarda la vaccinazione contro il Papillomavirus. Ma nonostante le buone intenzioni, i ritardi accumulati in pandemia sono impegnativi da recuperare.
Screening e vaccinazione
Per colpa del virus pandemico le attività di screening e di vaccinazione hanno subito un’ulteriore flessione: in particolare, come rilevato dal ministero della Salute, la vaccinazione anti-Hpv è risultata essere quella la cui somministrazione è stata maggiormente ridotta.
Gli ultimi dati sulle coperture vaccinali al 31 dicembre 2022 dimostrano che i ritardi accumulati durante la pandemia non sono ancora stati colmati. Nonostante si registri qualche miglioramento nei dati per quasi tutte le coorti di età rispetto al 2021, i tassi medi di copertura per maschi e femmine sono ancora molto lontani dall’obiettivo del 95% fissato dal PNPV. Al 31 dicembre 2022 le ragazze nella coorte più giovane (2010) che compivano 12 anni nell’anno di rilevazione e vaccinate con ciclo completo erano il 38,78%, percentuale lievemente superiore al 2021 (32,22%) e al 2020 (30,32), ma non sufficienti per tornare ai livelli del 2019 (41,60%).
Anche i dati riferiti alla popolazione maschile segnalano lievi miglioramenti, non ancora tuttavia soddisfacenti. Le rilevazioni riferite alla popolazione maschile seguono in particolare lo stesso trend della controparte femminile: i ragazzi della coorte più giovane (2010) che hanno concluso il ciclo vaccinale sono poco più del 30% (31,81%), contro il 46,83% della coorte del 2009 (ragazzi che compivano 13 anni nell’anno di rilevazione). Rispetto alla precedente rilevazione del 2021, sulle stesse fasce di età si osserva un incremento del 5,06% per i ragazzi che compivano 12 anni nell’anno di rilevazione e del 2,84% per i ragazzi che compivano 13 anni nell’anno di rilevazione. Inoltre, si registra ancora una forte variabilità tra Regioni nei tassi di immunizzazione.
I vulnerabili
Questi dati segnalano non solo che esiste un’ampia fetta della popolazione adolescenziale non protetta. Si stima infatti che, nel complesso, tra 1,1 e 1,3 milioni di giovani adolescenti nati tra il 2005 e il 2009 non saranno protetti contro le malattie legate all’Hpv nel corso della loro vita generando costi sanitari e sociali stimati in 905 milioni di euro. Se invece gli obiettivi di copertura previsti dal piano nazionale fossero raggiunti, si potrebbe ottenere un risparmio pari a 529 milioni.
Per quanto riguarda invece i dati riferibili alla prevenzione secondaria, nel 2021-2022 risulta che in Italia il 78% delle donne fra i 25 e i 64 anni di età si è sottoposta allo screening cervicale (Pap-test o Hpv test) a scopo preventivo, all’interno di programmi organizzati o per iniziativa personale. Tuttavia, permangono delle nette differenze tra le regioni del nord e quelle del sud. Infatti, la copertura dello screening cervicale disegna un netto gradiente geografico Nord-Sud che divide l’Italia in due, con coperture mediamente pari all’84% nelle Regioni del Nord e Centro Italia (93% nella P.A. di Bolzano) e 69% nelle Regioni del Sud (con coperture minime per alcune Regioni come il Molise 53% o la Calabria 62%).
Infine una quota non trascurabile di donne 25-64enni intervistate riferisce di non essersi mai sottoposta allo screening cervicale (11%) o di averlo fatto da più di tre anni (13%).
Per tutte queste ragioni, una comunicazione più capillare e incisiva sui rischi delle malattie collegate a Papillomavirus è importante per recuperare i gap accumulati e promuovere le buone pratiche di prevenzione.
L’appello
I firmatari del Manifesto richiedono dunque che il Governo italiano adotti gli obiettivi sanciti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea nello Europe’s Beating Cancer Plan per eliminare i tumori da Hpv prevedendo azioni e tempi definiti in linea con la strategia internazionale.
“In particolare, come già sta avvenendo in altri Paesi, al fine di raggiungere l’eliminazione, si rende necessario entro il 2030: vaccinare almeno il 90% della popolazione target; assicurare che almeno il 90% della popolazione target abbia accesso agli screening cervicali gratuiti (il Piano europeo contro il cancro intende tagliare questo traguardo entro il 2025); trattare almeno il 90% dei casi di cancro cervicale e lesione precancerosa; prevedere iniziative di comunicazione per aumentare la comprensione e la sensibilizzazione del pubblico, dei pazienti e degli operatori sanitari sull’Hpv e sulle relative strategie di prevenzione vaccinale, screening precoce e cura”.
Un piano straordinario
Per poter raggiungere questi risultati, si chiede alle Istituzioni italiane l’approvazione di un Piano straordinario di recupero delle vaccinazioni anti-Hpv e dello screening cervicale. Come? Utilizzando le risorse residue del Fondo prevenzione, coinvolgendo medici di medicina generale, pediatri, farmacie e specialisti e promuovendo l’ampliamento dell’accesso ai servizi di vaccinazione attraverso l’individuazione di nuovi siti vaccinali e l’organizzazione di open day e altre giornate dedicate alla prevenzione.
Garandento inoltre “una maggiore uniformità a livello di Regioni e Asl, per esempio attraverso l’inserimento della vaccinazione anti-Hpv all’interno degli indicatori inclusi nel Nuovo Sistema di Garanzia per la verifica dell’erogazione dei Lea;
monitoraggio puntuale del target stabilito all’interno del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, dove si chiede di vaccinare il 95% delle ragazze e dei ragazzi”. Identificando best practice locali da condividere nell’ambito di tavoli istituzionali, cui far partecipare anche rappresentanti delle associazioni e società scientifiche, al fine di estenderne l’applicazione e creare un modello efficiente.
Infine si sollecita “l‘attivazione di campagne di informazione ed engagement sulla prevenzione dei tumori da Hpv“, con informazioni basate sulle evidenze scientifiche, anche sui social media, al fine di aumentare la consapevolezza sulle malattie causate dall’HPV nella popolazione generale e con un’attenzione particolare ai giovani e ai genitori; ma anche programmi di corretta informazione e sensibilizzazione nelle scuole primarie, per i genitori degli studenti, e nelle scuole secondarie, per i giovani, circa le malattie sessualmente trasmissibili e la prevenzione dei tumori Hpv-correlati;
prevedendo il coinvolgimento di medici (in particolare MMG e PLS) e operatori sanitari per informare correttamente circa l’importanza di aderire al piano vaccinale e ai programmi di screening.
I firmatari del Manifesto suggeriscono anche di attivare “una rete di giovani “ambasciatori” che diffondano tra i pari l’importanza del tema, coinvolgendoli in un processo spontaneo di condivisione di buone pratiche, raccontando le proprie esperienze; usando sistemi digitali per invitare la popolazione non vaccinata e avente diritto e sistemi di richiamo automatico per completare il ciclo”.
Attenzione anche al monitoraggio dei livelli di copertura vaccinale e di screening, “attraverso strumenti digitali” con una cadenza almeno semestrale. Per tener conto dei progressi ed eventualmente correggere la rotta.