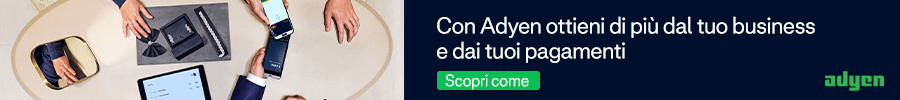Tanti volti. Spesso difficili da identificare. Ci si sente stanchi, si ha poca voglia di mangiare, muscoli e articolazioni cigolano e sono dolenti. Come se ci fosse un virus o, piuttosto, se il peso degli anni si facesse sentire troppo. In realtà, seppur per fortuna raramente, dietro questa situazione potrebbe esserci la mielofibrosi.
Siamo di fronte ad una malattia molto eterogenea, che presenta circa da 500 a 700 nuove diagnosi l’anno in tutta Italia e concentra i primi segni più frequentemente tra i 60 e i 70 anni.
Tre geni chiave per la mielofibrosi
Grazie alle ricerche più recenti, si è capito come nasce questa patologia tumorale del midollo osseo ed il ruolo di tre geni, con annesse mutazioni che vengo definite driver perché essenziali per la comparsa della malattia stessa.
La principale, che accomuna oltre la metà dei pazienti, è la mutazione V617F di JAK2, un gene importante per il controllo della produzione delle cellule del sangue, che, se mutato, risulta associato a una loro proliferazione incontrollata. Proprio per agire su questo fronte è ora disponibile di una nuova terapia grazie a momelotinib, un inibitore orale di JAK1/JAK2 e del recettore dell’activina A di tipo 1 (ACVR1).
Il nuovo farmaco
Si tratta del primo medicinale autorizzato, stando a quanto riportano gli enti regolatori, “per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con anemia da moderata a severa che sono affetti da mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale e che sono naïve agli inibitori della chinasi Janus (JAK) o già trattati con ruxolitinib”.
Tornando alle mutazioni e ai geni la seconda per frequenza è quella del gene CALR, presente nel 25-35% dei casi e alla base della produzione di una proteina, la calreticulina, coinvolta nella regolazione di processi come la proliferazione, la crescita, la migrazione e la morte cellulare. L’ultima mutazione è nel gene MPL, coinvolto invece nella produzione di piastrine, riscontrata nel 3-5% dei pazienti. “Le tre mutazioni sono presenti in circa il 90% dei pazienti, mentre il resto presenta mielofibrosi “triplo-negativa”, spiega Alessandro Vannucchi, direttore della Sod Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, ordinario di Ematologia – Università di Firenze.
Cosa succede in caso di malattia?
Sostanzialmente il midollo viene sostituito da tessuto fibroso, con conseguente sovvertimento di struttura. Così si altera la produzione normale delle cellule del sangue, dai globuli rossi fino ai bianchi ed alle piastrine. La patologia è ovviamente cronica. Inizia da una fase precoce, o pre-fibrotica, perché non è presente ancora la fibrosi del midollo osseo.
Nella fase avanzata compare la fibrosi midollare e si evidenzia una fuoriuscita di cellule staminali immature dal midollo osseo. Queste, attraverso il sangue, raggiungono la milza e il fegato, dove si accumulano. Solitamente, quando la malattia si manifesta, sono già presenti le alterazioni tipiche: oltre alla fibrosi, tra le altre, l’anemia e l’ingrossamento della milza. In alcuni casi (10-15 su 100) la mielofibrosi può evolvere in una patologia più severa: la leucemia mieloide acuta.
Individuare nuove terapie è fondamentale. L’unica cura potenzialmente risolutiva è il trapianto di midollo, ma è riservato a una piccola percentuale di pazienti, in genere sotto i 70 anni, per via della complessità e dei rischi ad esso associati. Per il resto si punta sui farmaci. Ed in questo senso la ricerca va avanti, focalizzandosi proprio sui JAK Inibitori. Questi hanno la capacità di bloccare la via di segnalazione JAK STAT attivata nelle cellule che è responsabile della crescita abnorme delle cellule del sangue, ma anche di una serie di sintomi, del deposito di fibre e soprattutto della splenomegalia, l’ingrossamento della milza.