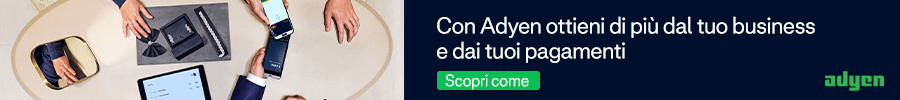Siamo alle prese con un inverno demografico senza fine, destinato a impattare anche sul mondo del lavoro e, in definitiva, sul Pil del Paese. L’Istat segnala un record negativo dietro l’altro sul fronte della natalità.
“Ma attenzione: questo dato è il frutto di due fattori, da un lato quanti figli si fanno in media, dall’altro il totale di donne e uomini in età riproduttiva. Il numero dei nati, insomma, dipende non solo dalla propensione delle coppie a fare figli, ma anche dal contingente dei potenziali genitori. E c’è da dire che in Italia facciamo sempre meno figli dagli anni ’70”, sottolinea Daniele Vignoli, professore ordinario di Demografia all’Università di Firenze.
“Nel 1984 siamo scesi per la prima volta sotto 1,5 figli per donna e così è stato fino ad oggi. Nel 2024 l’Italia ha compiuto 40 anni di bassa fecondità e dunque al momento il problema non è tanto dove sono i figli, ma che fine hanno fatto i genitori”.
La trappola demografica
Sembra un serpente che si morde la coda.
“Anche se l’anno prossimo, improvvisamente, in Italia facessimo molti più figli della media – spiega – il numero di nati non potrà che diminuire lo stesso, perché saranno sempre meno i genitori. È chiaro che buone politiche di fecondità possono far risalire un po’ le nascite, ma gli effetti sulla popolazione e sulla forza lavoro si vedranno tra 20 anni, quando il contingente dei nati di oggi diventerà, a sua volta, genitore”.
Insomma, non possiamo pensare che una buona politica abbia un effetto a breve termine sull’inverno demografico, perché a mancare ormai sono proprio gli aspiranti mamme e papà.
Come invertire il trend (e la natalità)
Ma cosa fare per riportare la ‘primavera demografica’ nel nostro Paese? Le politiche per la fecondità possono trarre spunto dalla scienza. “Oggi sappiamo cosa funziona nel contesto italiano e cosa no. Abbiamo in pubblicazione su ‘Demography’ un articolo (firmato insieme a Raffaele Guetto e Giammarco Alderotti, ndr) proprio su questi aspetti.
Abbiamo analizzato il nesso tra politiche familiari e fertilità, valutando il potenziale ruolo dei congedi parentali, dei servizi di assistenza all’infanzia e degli assegni familiari sulla fecondità”.
I ricercatori dell’Università di Firenze hanno intervistato 4.022 persone tra i 20 e i 44 anni, esponendole a vari scenari, caratterizzati da diversi ‘pacchetti’ di politiche familiari.
“Ebbene, quello che è stato percepito come fondamentale dalle persone non sono le leggi pro natalità, i baby bonus o gli incentivi economici, non sono tanto e solo gli aspetti legati ai congedi, quanto la disponibilità di asili nidi e il fatto di avere una coppia con due persone che lavorano e che possa contare così su un reddito dignitoso. Insomma, quello che si dovrebbe fare, se davvero si vuole invertire la tendenza, è una politica che mira al benessere anche economico della coppia. A quel punto, se c’è desiderio di genitorialità, i figli si faranno”, assicura Vignoli.
Nessuno decide di mettere in cantiere un bambino “perché forse domani gli daranno un baby bonus, ma perché c’è una situazione di coppia e una stabilità economica che permette di farlo”, ragiona il demografo.
Se lei lavora…
Un altro discorso interessante è legato al lavoro femminile. Oggi, soprattutto al Sud, dopo il primo figlio spesso le donne si trovano a costrette a rinunciare alla propria professione per dedicarsi alla famiglia.
“Ma i dati parlano chiaro: il lavoro femminile non scoraggia la natalità, anzi al contrario la stimola. Certo, questo accade nelle aree in cui ci sono servizi che consentono di conciliare genitorialità e lavoro”, dice Vignoli.
Non è un caso, secondo l’esperto, che nel Nord Italia la relazione tra lavoro femminile e natalità sia positiva: “In alcune Regioni e Comuni in cui le donne lavorano di più, si fanno più figli. Nel Meridione invece la relazione rimane negativa, perché mancano politiche di supporto come appunto gli asili nido. Ma è bene essere chiari: in tutti i Paesi europei in cui il tasso di lavoro femminile è più elevato, si fanno più figli”. Chi dice il contrario si attacca a una visione vecchia, valida “fino a metà anni ’80”.
Il fatto che al Sud lavoro e natalità facciano fatica ad andare a braccetto è spia, secondo l’esperto, della necessità di “interventi mirati, che permettano di conciliare figli e lavoro femminile. C’è da dire che in generale le stesse politiche di conciliazione in Italia sono molto indietro. Insomma, c’è un problema strutturale di asili e di servizi che ostacola il desiderio di natalità, ma non è lasciando le donne a casa che si faranno più figli. Sappiamo anzi che così si ottiene l’effetto opposto. Il secondo reddito nella coppia aiuta tantissimo in questo momento”. Come capire se le politiche adottate stanno funzionando? L’esperto assicura che la decelerazione del calo delle nascite potrebbe vedersi già nel breve termine.
In Italia fare figli non è cool
Ma quanto conta l’immaginario nel progetto di un figlio? “Questo è un tema interessante. In generale – dice il professore – tutte le politiche devono essere accompagnate da un clima più amichevole nei confronti della famiglia e dei bambini. Non c’è dubbio che la popolazione sia influenzata non solo dalla situazione contingente oggettiva, ma anche dal clima generale verso la famiglia e gli aspetti genitoriali. A dircelo è anche un’altra ricerca, in cui abbiamo messo in relazione 20 anni di notizie economiche del Tg1 con la natalità: si vede che quando si parla un po’ meglio dell’economia e la visione non è negativa, questo ha un impatto sulla propensione a fare figli”.
Insomma, tutti abbiamo le nostre responsabilità e un clima catastrofico e catastrofista non aiuta. “In un momento storico di grande incertezza geopolitica, economica e anche sul piano della salute, diventa difficile immaginare il futuro. Fare un figlio è intrinsecamente incerto, ma a tutto ciò aggiungiamo l’incertezza contingente del nostro tempo. Questo secondo me è un aspetto cruciale: oltre al fatto di avere o no un lavoro, entra in gioco il tema della percezione della genitorialità. Non so se il punto chiave sia trasmettere l’idea che fare figli è cool, ma sicuramente lo è un atteggiamento un po’ più positivo sul futuro”.
Natalità in Italia
Un calo senza fine, quello del numero di neonati nella Penisola: nel 2023 siamo scesi a 379.890, -3,4% sull’anno precedente. E la discesa prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori Istat relativi a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Così anche il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (quando eravamo a 1,24). E la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21.
Natalità: l’inverno demografico contagia l’Europa, un’alleanza per uscirne