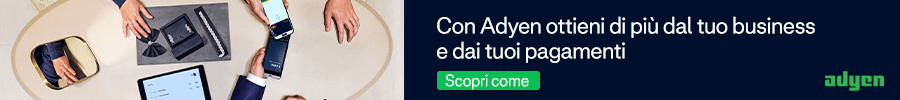Gli adolescenti italiani stanno cambiando sotto i nostri occhi. Nel mirino di Giuseppe Nicolò, medico psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche della Asl Roma 5, ci sono “la mania per i social e l’iperconnessione, ma anche l’uso di cannabis“, che lo psichiatra definisce come una “fra le droghe più pericolose a disposizione per i giovani”. E fra poco vedremo il perché.
“Stiamo constatando un aumento non solo dell’isolamento sociale, ma anche della solitudine: una dimensione esistenzale per cui i contatti umani, che sono necessari anche al nostro cervello per riconoscere le emozioni dell’altro, per interagire e avere una socialità sia fisica che mentale, sono stati sostituiti da alcune condotte altamente gratificanti, che danno un soddisfacimento immediato”. Un effetto potente, che sta modificando le abitudini di una generazione.
Droghe leggere?
Sulla cannabis e gli effetti sulla mente dei giovanissimi “c’è tantissima letteratura scientifica”, dice a Fortune Italia Nicolò, convinto che “parlare di droghe leggere sia sbagliato: la cannabis provoca danni al cervello in fase di sviluppo, compromettendo la connessione fra gli emisferi e comportando una perdita di sostanza grigia. Questo, certo, non vale per tutte le persone che fumano cannabis, ma pensiamo che il 25% di quanti vanno incontro a una psicosi non la avrebbero mai sperimentata se non avessero usato questa sostanza”.
“Non solo: sappiamo che la cannabis anticipa di 5-10 anni l’esordio di una eventuale malattia psichiatrica e che, nelle persone in cui la cannabis provoca questi effetti, il 70% dei casi rimarrà in quella condizione. Insomma, si fa confusione tra intossicazione da cannabis (quando mi sveglio con il mal di testa dopo aver fumatio) e i sintomi psicotici come deliri e allucinazioni. Nel secondo caso – scandisce lo psichiatra – il rischio è quello di un effetto mediato da un danno al sistema nervoso centrale, che si mantiene anche se si smette”.
Se a dare dipendenza è il telefonino
Ad accendere i riflettori sull’effetto dei device è invece un recente lavoro del Consiglio nazionale delle ricerca: stando allo studio in Italia il numero degli adolescenti Hikikomori, che si isolano dai coetanei e dal resto del mondo reale per vivere nella dimensione virtuale, è quasi raddoppiato dopo gli anni della pandemia e quello dei ‘lupi solitari’ sia addirittura triplicato.
Nicolò è convinto che “la cybersecurity, intesa come l’uso in sicurezza dei device, dovrebbe essere insegnata alle elementari: noi diamo telefonini e tablet a ragazzini di 8-9 anni, senza informarli dei rischi. Che non sono solo quelli di eventuali predatori. Dobbiamo insomma assicurare un’educazione all’uso dello strumento elettronico ad adulti e adolescenti. Questo dispositivo infatti soddisfa emozioni e richieste immediate, distogliendoci da attività che richiedono tempo, fatica e pazienza. Ma che aiutano a crescere. Tutto questo fa male al nostro sviluppo, al nostro cervello e alla società“.
Meno umani
Il risultato dell’iperconnessione di questi anni è ormai sotto i nostri occhi. “Abbiamo ragazzini – continua lo psichiatra – che non hanno le skill per il corteggiamento romantico, una cosa che si imparava a scuola, con le prime cotte. Per relazionarsi con i coetanei usano il device. E tutto questo ci sta rendendo meno umani”.
Allora cosa fare? Dovremmo “reimparare l’attesa, la suspance, a guardare negli occhi l’altro per coglierne le emozioni, non le emoticon“, suggerisce Nicolò, scherzando ma non troppo.
Lo specialista è convinto che “siamo in tempo a cambiare mentalità. Quindi va bene lo sforzo verso la digitalizzazione, ma non deve comportare una de-umanizzazione. Se”, come ci dice il recente studio del Cnr, “si ha più piacere a stare con un device che con un amico, la situazione dal mio punto di vista diventa preoccupante”.