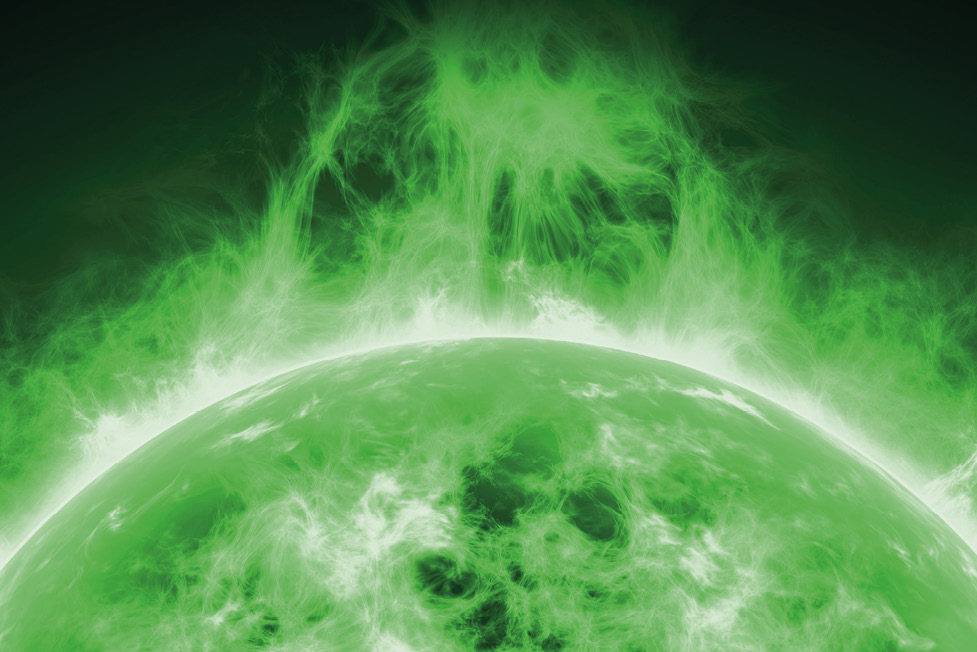L’idrogeno non è una fonte di energia classica come il sole o il petrolio, ma un vettore energetico. C’è infatti bisogno di energia (elettrica) per “spaccare” l’acqua con la tecnologia degli elettrolizzatori. Una molecola difficile da maneggiare e trasportare, che l’energia la restituisce attraverso le celle a combustibile, che generano elettricità e hanno come scarto innocuo il vapore acqueo. In altri termini è un modo per accumulare e rilasciare energia, utile per non sprecare l’elettricità prodotta dalle rinnovabili e non utilizzata. A conti fatti potrebbe essere usato per risolvere il problema della decarbonizzazione dei settori dove non esistono ancora batterie in grado di accumulare direttamente l’elettricità che serve, come navi, treni e aerei che oggi bruciano derivati del petrolio, o nei settori cui serve tanto calore, come le industrie della ceramica o le acciaierie.
Lo scenario immaginato dal governo ha come premessa di fondo l’inadeguatezza, l’insufficienza, la non programmabilità delle fonti rinnovabili. Per questo il nucleare, per lo stesso motivo l’idrogeno. E a tendere, con i progressi della ricerca scientifica, anche l’idrogeno prodotto attraverso gli elettrolizzatori dall’elettricità generata dalle centrali nucleari. Per generarlo siamo di fronte a tre scenari da qui al 2050 (uno con prevalenza di produzione nazionale, uno con prevalenza di importazione, uno misto). Bisognerà costruire una capacità di elettrolizzatori rispettivamente per 15-30 gigawatt o per 4-9, con investimenti variabili tra gli 8 e i 16 miliardi nel primo scenario, e tra i 2 e i 5 nel secondo scenario. Già oggi, ha ricordato il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il settore «può contare su risorse complessive superiori ai 6 miliardi».
Secondo il documento appena presentato dal governo gli attuali costi associati all’idrogeno sono elevati, ma c’è una prospettiva di riduzione sia per la produzione sia per l’approvvigionamento dall’estero grazie a un importante contributo derivante dall’import dai paesi del Nord Africa. Nella prima fase di sviluppo della strategia sono necessarie misure di sostegno per garantire investimenti, competenze ed occupazione, oltre a sviluppare infrastrutture di trasporto a media e grande distanza (pipeline, come il Southern Hydrogen Corridor) e trasporto su nave dai porti. La strategia punta sullo sviluppo dell’idrogeno verde, sfruttando sinergicamente sia il potenziale dell’idrogeno blu (Ccs), sia il possibile contributo, in chiave prospettica, dell’idrogeno ottenuto da fonte nucleare.
Entro il 2030 l’industria mondiale potrebbe produrre più di 20 megatoni all’anno di idrogeno verde, o l’equivalente di +200 gigawatt di capacità di elettrolizzatore, che potrebbe aumentare di dieci volte entro il 2050. Tuttavia, i colli di bottiglia ostacolano la consegna tempestiva degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile necessarie. Ciò a sua volta ha il potenziale per esacerbare la competizione regionale tra Europa, Stati Uniti e Asia per ottenere il sopravvento nello sviluppo ulteriore della tecnologia e nella produzione dell’idrogeno stesso. I produttori occidentali di apparecchiature per l’idrogeno stanno già perdendo il loro vantaggio tecnologico rispetto al resto del mondo, e in particolare ai player cinesi. Oggi l’Italia consuma 1,5 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) di idrogeno, utilizzato quasi solo (99%) nel settore industriale, principalmente per raffinazione e chimica (ammoniaca e fertilizzanti).