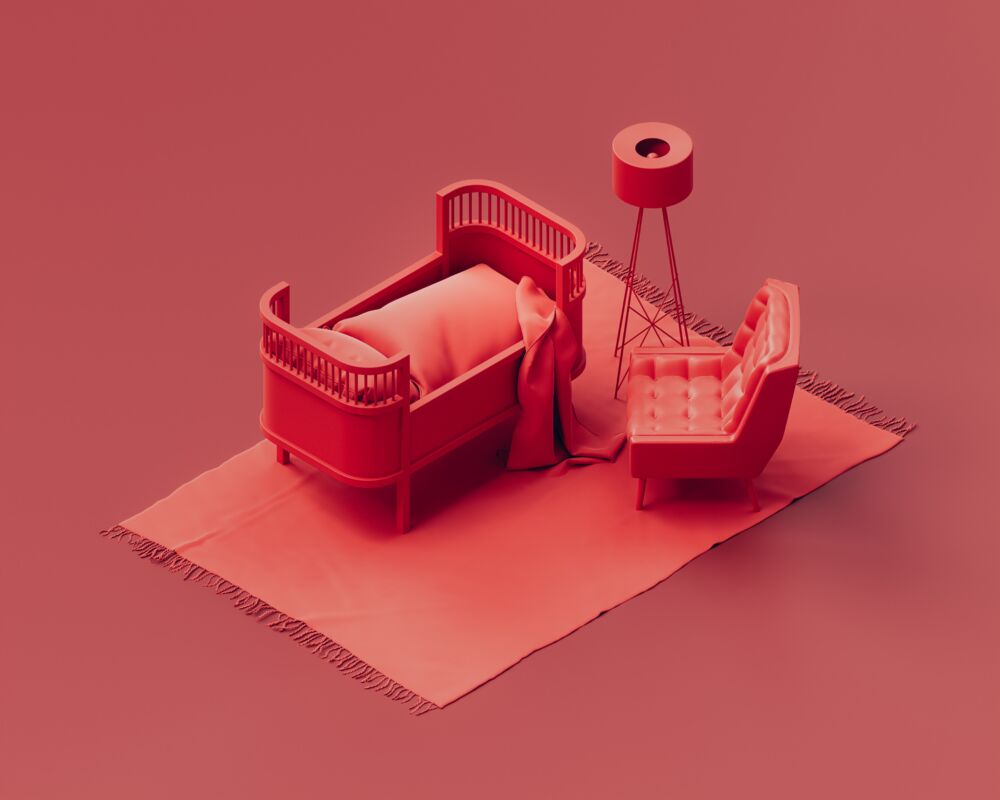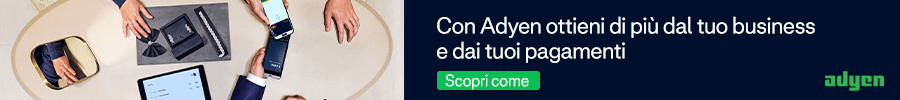La crisi demografica contagia il Vecchio Continente e ne insidia il futuro. A Parigi il confronto su rischi e strategie contro l’inverno delle culle.
Un continente sempre più vecchio. Non è solo l’Italia a fare i conti con l’inverno demografico. Il calo della natalità sembra essersi diffuso come un virus in Europa, senza curarsi troppo dei confini, naturali o fissati dall’uomo. In Gran Bretagna, per la prima volta in quasi mezzo secolo, stando all’Office for National Statistics, nel primo semestre 2023 i decessi hanno superato le nascite, con un tasso di fertilità che già era sceso a 1,49 figli per donna (dato 2022), molto al di sotto dell’ormai noto tasso di sostituzione necessario per mantenere una popolazione stabile (2,1). Anche i dati Eurostat confermano il trend: nel 2022 il tasso di fertilità era pari a 1,16 in Spagna, 1,24 in Italia e 1,29 in Polonia. E se la Francia, con 1,79 figli per donna, si piazzava comunque al di sopra della media europea (a 1,46), nemmeno Oltralpe dormono sonni tranquilli. Nel 2023 il dato nel Paese è sceso a 1,68 (dati Insee). Un fenomeno che, inevitabilmente, impatterà sull’economia.
Secondo Morgan Stanley l’invecchiamento della popolazione potrebbe ridurre del 4% il Pil dell’Eurozona entro il 2040. Tutto questo sulla base delle previsioni secondo cui la popolazione in età lavorativa si ridurrà del 6,5% entro il 2040. Intanto già oggi l’infertilità colpisce 25 milioni di persone in Europa.
A mettere sotto la lente la crisi della natalità sono stati medici, ricercatori, associazioni di pazienti e decisori politici europei riuniti nelle scorse settimane a Parigi sotto l’egida del professor Samir Hamamah, presidente della Federazione francese per gli studi sulla riproduzione (FFER). Un incontro organizzato con il supporto della tedesca Merck per analizzare le strategie per cambiare le cose.
Un declino dalle radici antiche
“I tassi di fertilità nel mondo sono declinati drammaticamente a partire dal 1950 e continueranno a farlo in quasi la totalità dei Paesi fino al 2100”, stima Hamamah, che parla senza mezzi termini di demographic divide: mentre i Paesi occidentali fanno i conti con un inverno demografico che appare senza fine, in altri territori a basso reddito si registrano tassi di fertilità comparativamente più alti. Meno culle significano meno persone, con importanti ricadute economiche: “La contrazione e l’invecchiamento della popolazione porteranno a serie sfide economiche e a una pressione crescente sui sistemi sanitari”, prevede Hamamah. Un tema che si lega a quello dell’infertilità. “La qualità del seme dei nipoti è peggiore rispetto a quella dei nonni: anche la salute riproduttiva degli uomini è in crisi”.
La ‘crisi’ del modello francese
Se in Italia si guarda spesso alla Francia come Paese modello per le politiche fiscali e il welfare pro-natalità, la realtà è che tutto ciò non sembra più essere sufficiente. I genitori francesi possono lavorare part-time nei primi anni di vita dei figli, la rete degli asili nido è giudicata positivamente dalle famiglie e la pressione fiscale si riduce in base al numero di figli a carico. Ma negli ultimi anni queste misure sono state ‘limate’. Risultato? Nel 2023 il Paese ha registrato meno di 700mila nascite, il dato più basso dal 1946. Non solo: in Francia circa una coppia su quattro che desidera un figlio non riesce ad arrivare alla gravidanza dopo 12 mesi o più, termine corrispondente alla definizione di infertilità da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. Una situazione che riguarderebbe circa 3,3 milioni di francesi. Il calo demografico ha portato Macron ad annunciare a inizio anno un piano per rilanciare le nascite e contrastare l’infertilità, anche attraverso l’estensione a 6 mesi del congedo per la nascita di un bebè. “Bisogna fare di più”, dice Hamamah.
Questione di tempo
E in Italia? Nel 2022 il 67,4% dei 18-34enni viveva in famiglia (era il 59,7% nel 2002). La tendenza è a rinviare matrimonio e figli, con l’età media delle primipare salita a 31,6 anni dai 29,7 nel 2002. Insomma, gli italiani non solo fanno meno figli, ma iniziano a pensarci sempre più tardi. Come evidenzia a margine dell’incontro Nicola Colacurci, past-president della Società italiana di ginecologia e ostetricia, a frenare le nascite da noi è anche una questione di programmazione: “Se si inizia a pensare a un figlio ben dopo i 30 anni, è molto difficile arrivare al terzo. Il tema è complesso e se i figli si fanno via via più tardi, saranno sempre meno”.
Secondo l’esperto è prioritario non solo informare le persone in modo corretto sui rischi per la fertilità e la salute legati alle scelte di vita, ma anche “rendere gratificante il pensiero della gravidanza. Oggi anche fra le giovani generazioni il modello di gratificazione prevalente sul lavoro è di tipo maschile. Sono convinto che, se la maternità tornerà ad essere gratificante, le cose cambieranno”, sottolinea l’esperto. “Poi c’è un altro tipo di problema: purtroppo è molto radicata la convinzione che, grazie alla scienza, si possano superare tutti i limiti. Ma non è così”. Avete presente i titoloni sulle mamme da record a 50 e più anni?
Occhio agli inganni
I successi delle tecniche di fecondazione assistita hanno favorito l’idea “che la scienza potesse risolvere tutto”, puntualizza Paola Anserini, presidente Società italiana di fertilità e sterilità (Sifes-MR). Risultato? La tendenza è stata quella di posticipare, tanto poi se qualcosa non va c’è la Pma. “Nel 2005 l’età media delle donne che si sottoponevano a cicli di fecondazione assistita era di 35 anni, con il 20,7% di over 40. Nel 2021 – racconta – è salita a 36,8 anni, con le over 40 diventate il 34,4%”. Con l’età, aumentano le difficoltà a concepire e si riduce il numero di bambini che nascono.
Anche sulla crioconservazione degli ovociti, tecnica di cui ora si parla molto, occorre fare chiarezza. “Non è efficace al 100%: la sua reale efficacia è collegata all’età del prelievo e al numero di ovociti raccolti”, puntualizza Anserini, ricordando che si tratta di una scelta che andrebbe fatta “prima dei 34 anni”. La stessa Pma “è uno strumento per trattare delle patologie, non l’invecchiamento: non bisogna rinviare troppo la scelta di un figlio. Se qualcosa non va, è bene rivolgersi subito a specialisti della fertilità”, raccomanda l’esperta.
Uscire dalla denatalità
L’idea degli specialisti riuniti a Parigi è che la crisi della fertilità in Europa richieda una mobilitazione collettiva, a partire da tre questioni chiave: sensibilizzazione, accesso alle cure e rafforzamento delle politiche pubbliche. Stereotipi e idee sbagliate tra i giovani rischiano di intaccare il progetto di un figlio. E la concezione della scienza come soluzione sempre e comunque efficace, come abbiamo visto, può portare a sottostimare elementi come il calo di fertilità legato all’avanzare dell’età. “Un tema, quello della corretta informazione, importante anche per i medici: occorre smettere di dare risposte tranquillizzanti alle donne in caso di dubbi e preoccupazioni e parlare loro con chiarezza, invitando ad approfondire eventuali problemi con uno specialista”, raccomanda Colacurci. La buona notizia è che “la problematica è stata presa in carico in Italia dalle istituzioni, che era quello che noi come Società scientifica volevamo”. Perché senza figli non c’è futuro.