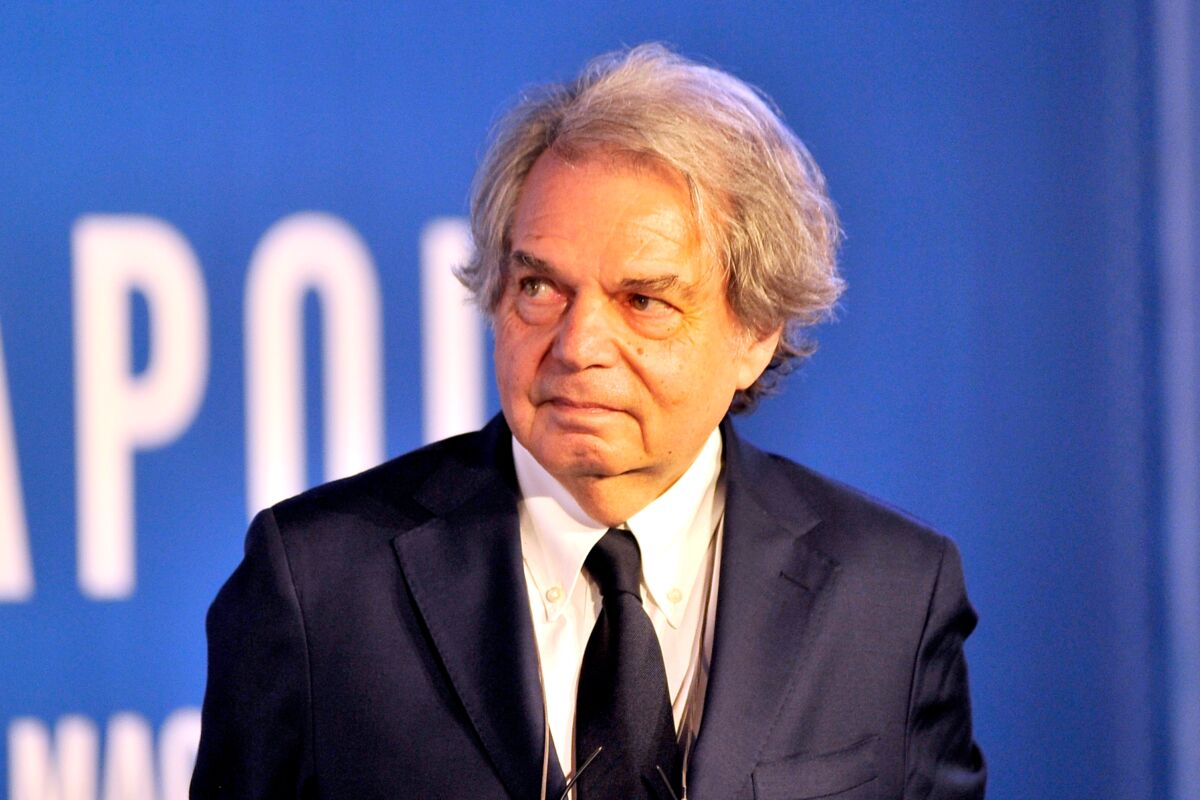Grazie al MOSE, Venezia non sarà più allagata. È un risultato straordinario, opera di ingegno e di costanza contro le diverse avversità che si sono manifestate negli oltre 50 anni che hanno seguito la grande alluvione del 1966. Dal 3 ottobre 2020, il MOSE è entrato in funzione più di 50 volte, e la sua operatività è oggi condizione necessaria per la sopravvivenza della città, ma non sufficiente.
Infatti, la sfida della salvaguardia di Venezia non si può dire completamente vinta, ed il vero pericolo non viene dai cambiamenti del clima. Perché Venezia non è fatta solo di pietre, ed il suo destino è collegato alla presenza di tutti gli elementi umani che caratterizzano una città. Una vera città, non un contenitore, sia pur bellissimo e visitato da milioni di persone l’anno.
Paradossalmente, Venezia non dovrebbe esistere. Nessuno oggi costruirebbe una città dentro una laguna, in un terreno paludoso, difficile da raggiungere, privo di sorgenti di acqua dolce. Non dovrebbe esistere nemmeno la sua laguna, almeno nella forma che siamo abituati a vedere. Le lagune sono infatti strutture geologiche effimere, costruite dall’interazione di fiumi carichi di sedimenti ed il mare: possono interrarsi, a causa dei sedimenti fluviali, oppure diventare mare, se la forza delle mareggiate è in grado di sopraffare le difese dei litorali. Questo è stato il destino, in epoca storica, di molte lagune della costa adriatica.
La città di Venezia si è formata per rispondere ad una necessità: dopo la caduta dell’impero romano, le isole lagunari offrirono rifugio a popolazioni in pericolo, che si sono insediate in uno dei luoghi meno ospitali in assoluto. È il genio umano che, proprio per superare tali difficoltà, è riuscito a generare la più bella e prestigiosa città del mondo. La Serenissima Repubblica di Venezia già nel XVI secolo ha scelto di avere “come mura l’acqua e come tetto il cielo” (C.Sabbadino, 1540), deviando in mare la foce dei fiumi che erano in laguna, e costruendo nelle isole litoranee difese via via più resistenti alle mareggiate. Si è trattato di grandi opere di ingegneria, che hanno mobilitato migliaia di uomini e richiesto ingenti investimenti.
La laguna di Venezia, come la conosciamo oggi, è il risultato di una modellazione antropica secolare, che l’ha adattata alle necessità e agli obiettivi della società umana: è un ‘ecosistema antropico’ formatosi lungo il percorso del tempo, richiedendo costanti mediazioni fra i processi naturali e quelli artificiali, un prodotto paradigmatico dell’Antropocene.
Non c’è alternativa a continuare a gestire attivamente questo ecosistema, pena un suo rapidissimo degrado. La regolazione delle maree, che oggi il MOSE opera con efficacia, è una delle azioni necessarie, la più evidente; altre riguardano il ripristino morfologico, la cura dei canali di navigazione, assieme ad interventi di “restauro ecologico”, laddove le pressioni umane del passato non sono state rispettose.
Ma non si può capire Venezia ignorando la sua storia, anche quella economica. I fondatori di Venezia hanno effettuato una scelta di specializzazione economica precisa, nella produzione e commercializzazione di beni e servizi ad alto valore aggiunto. Sale e spezie, beni essenziali, ma non uniformemente disponibili, che dovevano essere trasportati. Ad essi si sono poi aggiunti altri beni, preziosi in quanto prodotti di manifatture uniche, che venivano esportati.
Nel viaggio di ritorno dall’Oriente, le navi della Repubblica erano obbligate a portare come zavorra, invece che acqua, pietre, ovvero i marmi che ancora oggi adornano le Chiese ed i Palazzi della Serenissima. Anche questo è genio: considerare la Bellezza come valore aggiunto (come potenza), ed eravamo nel Medio Evo. Così il Doge poteva stupire i suoi ospiti, che faceva passare dalla sua cappella privata, la Basilica di San Marco, prima di farli accomodare nel suo palazzo, per stringere qualche trattativa commerciale.
La sostenibilità di Venezia, città costruita in un ambiente ostile, si basava quindi su commerci di prodotti ad alto valore aggiunto, con altissimi margini di profitto, che permettevano investimenti (pubblici e privati) elevati. Inoltre, Venezia, una Repubblica che amava definirsi Regina del Mare, in un mondo che globalizzato non era, superava anche le frontiere del Mediterraneo. Si pensi alla via della Seta o alla via delle Spezie, ad altre vie di commercio, ma anche alle reti immateriali della cultura (editoria) che si riflette nella felice realtà urbana, ricco concentrato di bellezza e dirompente potenza. Per secoli qui si sono stampati quasi tutti i libri distribuiti in Europa.
Nel tempo, tuttavia, l’equilibrio tra le variabili in gioco muta. Dopo (molto dopo) la scoperta delle Americhe l’economia cambia direzione, i traffici si spostano verso il Nord Europa, e così la specializzazione particolare stabilita dai padri fondatori viene meno. Viene a diminuire di conseguenza quel valore aggiunto fondamentale per la sopravvivenza.
La città crede meno in sé stessa, la Repubblica cade nel 1796 e si consegna alle forze imperiali del centro Europa. Il periodo austroungarico segna una pesante decadenza economica: nel 1850 Ruskin descrive anche il degrado nelle “pietre di Venezia” ed il Regno d’Italia si allarga nel 1860 al Veneto, trovando però una Venezia povera, piena di mendicanti.
Una risposta arriva dall’industrializzazione della prima terraferma veneziana, cioè Porto Marghera, dove a partire dal 1917, sotto la spinta e secondo la visione di Giuseppe Volpi, venne realizzata una grande zona industriale, bonificando i terreni lagunari e costruendo canali artificiali navigabili e strade, collegando ogni azienda della zona alla rete ferroviaria nazionale.
Nel 1922 fu inaugurato il Canale Vittorio Emanuele, per collegare a Marghera il vecchio Porto, che era ancora nella città lagunare. Nel giro di pochi anni, tra il 1920 e il 1928, si insediarono a Marghera ben 51 stabilimenti attivi nel settore metallurgico, chimico, meccanico, cantieristico, petrolifero, elettrico. Ma Volpi era anche tra i fondatori della Compagnia Italiana Grandi Alberghi, che aveva l’hotel Excelsior del Lido come fiore all’occhiello, e come Presidente della Biennale istituì, nel 1932, la Mostra del cinema. Industria e cultura, ancora a braccetto.
Dopo i disastri della II guerra mondiale (Marghera venne pesantemente bombardata), le richieste del mercato indirizzano produzioni massive ed inquinanti: l’industrializzazione si rivela antitetica alla compatibilità ambientale, e molte produzioni vengono spinte a spostarsi altrove. In questo contesto arriva anche il turismo di massa e con esso inevitabilmente un’economia a basso valore aggiunto, che inoltre concorre a privare la città degli elementi essenziali, quali la casa per i suoi abitanti. Si manifestano dunque nuove pressioni, che si fanno più intense negli ultimi decenni del Novecento: crisi industriale, inquinamento, calo demografico e spopolamento, economia drogata dalla distruttiva monocultura turistica.
Il prezioso patrimonio, naturale e culturale, accumulato in quasi due millenni, viene avidamente divorato, e manca la capacità di generare valore per la sua necessaria manutenzione. L’alluvione del 1966 scuote le coscienze ed attrae una grande attenzione internazionale. Lo Stato italiano dichiara la salvaguardia di Venezia “preminente interesse nazionale”. La Legge Speciale per Venezia, votata dall’intero Parlamento italiano nel 1973, è quella che ha permesso la realizzazione del MOSE e di molti interventi in Città, anche a sostegno dei privati, con uno sforzo straordinario di tutta la collettività nazionale.
Ci sono voluti quasi trent’anni, ma il MOSE funziona anche se la sua realizzazione deve ancora essere completata. Dal punto di vista dei tecnici, la sfida maggiore di oggi è però quella di imparare a gestire una laguna “regolata” in modo sostenibile, ovvero rispettando i dinamismi naturali che adatteranno l’ecosistema ad una nuova situazione, con la presenza di inevitabili pressioni antropiche che dovranno essere minimizzate fin dove possibile e per la parte restante adeguatamente compensate.
La realizzazione delle barriere mobili ha richiesto più tempo e più denaro di quanto inizialmente previsto, soprattutto a causa di motivi non tecnici: ciò impone di pensare, guardando al futuro, all’importanza della dimensione umana. La salvezza derivante dal MOSE è a termine, in ragione dell’innalzamento dei mari derivante dal cambiamento climatico, inevitabile anche se non sappiamo quanto veloce esso sarà. Senza il MOSE, però saremmo già al collasso, ed invece oggi Venezia è la città costiera del Mediterraneo che è stata posta in sicurezza per prima, per i prossimi decenni, un tempo sufficiente per pensare al futuro della città ed all’adattamento della laguna nel XXII secolo. Abbiamo il tempo di studiare nuove soluzioni tecniche, che realizzeranno i nostri figli ed i nostri nipoti, se saremo in grado di offrire loro ed alle loro famiglie una città in grado di accoglierli, se riusciremo ad infondere in queste nuove generazioni lo spirito della storia millenaria di Venezia.
Capitale umano, coesione sociale e specializzazione produttiva ad alto valore aggiunto sono le condizioni per arrestare il declino della città e garantirle il futuro. Il rischio mortale per Venezia è lo svuotamento della sua base economica e, con esso, il progressivo svilimento del suo capitale umano. Serve per questo attivare una grande stagione di investimenti sostenibili a Venezia. FVCMS (Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità) ha individuato degli ambiti prioritari su cui concentrare l’attenzione nei prossimi anni e per ciascuno di essi sta sviluppando dei progetti specifici: Idrogeno, Transizione energetica e ambiente, Città campus, Residenzialità, Turismo sostenibile, Venice Sustainability Accelerator, Inclusione sociale, Legalità. Il “fattore umano” rimane al centro di questa strategia: ricordiamo ancora la storia di Venezia, quando le ricorrenti pestilenze decimavano la popolazione, i reggitori della città ordinavano di andare per il Mediterraneo cercando giovani che volessero venire a vivere qui, rifertilizzandola.
Venezia vuole diventare oggi la fucina di nuovi talenti, il laboratorio esperienziale dove si inventano e si sperimentano soluzioni nuove per le sfide planetarie: come è riuscita a realizzare la sfida, per alcuni impossibile, di adattare una città lagunare all’ innalzamento del mare, Venezia può indicare la strada per un nuovo equilibrio, inclusivo e sostenibile, tra produzione materiale, immateriale, ambiente e società. Un contributo concreto in questo senso può venire dal considerare il MOSE come un bene pubblico. Per questo dovrebbe essere aggiunto alla Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e il suo know-how, la progettualità, la cultura di questa esperienza, essere offerti dall’Italia al mondo alla prossima Conferenza ONU sui cambiamenti climatici. Venezia deve essere non solo oggetto passivo di visite: come ai tempi della Repubblica, dopo aver visitato i mosaici d’oro della Basilica di San Marco, finalmente protetti dalle inondazioni e restaurati secondo le più aggiornate tecniche da maestri specializzati, si andrà a discutere e progettare, qui, le nuove produzioni industriali e culturali.
La produzione di cultura è acceleratore di sostenibilità. La “cultura preservata” (musei) o quella “mostrata” (eventi, Biennale…) sono certamente fattori importanti. Ma è la produzione di nuova cultura, a 360 gradi, di nuovi saperi che riavvia i processi di sviluppo. Questo è racchiuso nel nostro slogan “Venezia, la più antica città del futuro”. Ripartire dalla storia, maestra di vita, con la stessa ambizione: se è possibile spostare i fiumi, bloccare i mari, niente è impossibile.
Per leggere integralmente lo speciale Mose, Ingegno Italiano clicca QUI
*Renato Brunetta, veneziano, economista, politico, saggista. Presiede il Cnel e la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. È stato Ministro per la PA nei governi Berlusconi IV e Draghi.