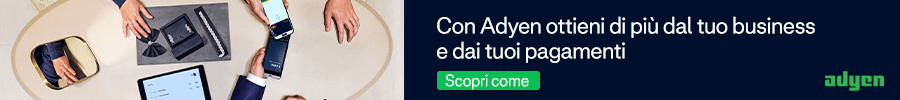Il ricercatore, si sa, è per natura un migrante. Va e si sposta dove lo portano le ispirazioni scientifiche e dove si trovano le tecnologie per valutare le sue teorie e affinarne l’impatto. Provare a definire questo flusso è sicuramente un’impresa, considerando come le sperimentazioni accelerano a passa veloce e quanto può essere impegnativo monitorare quanto avviene e quanto le persone si spostino come veri e propri traccianti da un laboratorio all’altro.
Ma è possibile prevedere dove e come nascerà una nuova Silicon Valley, capace di rappresentare un crogiuolo di intuizioni e rilevazioni scientifiche? E soprattutto, in questo percorso di sviluppo di poli ad alta tecnologia e a elevatissima competitività in ricerca, saranno le componenti umane a fare la differenza grazie ad un reclutamento mirato di esperti “su misura” per i programmi in sviluppo, o conterà di più la dotazione tecnologica del nocciolo strutturale che si va creando?
Domanda difficile. Ma una risposta, che può sicuramente aiutare a disegnare progettualità mirate per chi si orienta su questi modelli organizzativi, viene da una ricerca condotta dagli esperti del CSH (la struttura che si occupa da Scienza dei Sistema Complessi) presso l’Università di Vienna, pubblicata su Chaos, Solitons & Fractals.
Premessa necessaria: siamo di fronte ad un modello che, come tale, va assunto e che ovviamente non tiene in considerazione diverse variabili che potrebbero avere un impatto pesante. Ma comunque occorre ragionare su queste riflessioni, che vedono protagonisti gli esperti coordinati da Vito D. P. Servedio e Stefan Thurner.
L’analisi degli studiosi, realizzata attraverso l’utilizzo di sistema intelligenti per valutare una grandissima mole di informazioni (è stata considerata la banca dati Dimensions, che ha monitorato gli scienziati che si spostano attraverso le regioni del mondo in tre campi: semiconduttori, cellule staminali embrionali e ricerca su Internet), giunge ad una conclusione che fa riflettere.
A fare la differenza sul livello di attrattività scientifica di un determinato polo di ricerca non è (almeno inizialmente) il numero di ricercatori impegnati in un settore, quanto piuttosto le dotazioni tecnologiche dell’area. Come a dire che se una certa zona nasce già con una pingue dotazione strutturale avrà più modo di diventare attrattiva per gli studiosi del settore.
Meno impattante, secondo il modello di studio degli austriaci, è invece la componente quali-quantitativa di chi si dedica alla ricerca. Questa farà la differenza in futuro, anche per la capacità di richiamare “cervelli”. Ma nelle fasi iniziali non rappresenterebbe la variabile chiave per far decollare i centri scientifici, che invece partirebbero al meglio se sostenuti da investimenti iniziali davvero sufficienti a far ipotizzare un predominio nel settore prescelto.
E’ a quel punto che la mobilità degli scienziati diventa il traino per lo sviluppo delle discipline scientifiche. In questo modo gli autori dell’indagine provano a rispondere ad uno dei quesiti posti dal lavoro, ovvero se esiste o meno un numero minimo di studiosi per far decollare un settore di studio in una determinata zona geografica.
La risposta è negativa: non ci sarebbe una massa critica minima per far partire un polo di ricerca e farlo entrare nella top-ten internazionale, ma sarebbe piuttosto necessario studiare con cura e programmare sul fronte tecnologico.
Poi si può pensare a creare un pool di studiosi su misura. Senza dimenticare l’importanza del fattore tempo: chi ha l’intelligenza e la fortuna di individuare le aree della ricerca futura dotandosi di centri di primo livello avrà la possibilità di richiamare cervelli, produrre scienza e diventare polo attrattivo per alcuni anni.
Guidando il futuro. Con una leadership, rappresentata dalle pubblicazioni scientifiche, destinata a durare nel tempo. Anche grazie all’arrivo in massa di menti pronte a disegnare un futuro di successo.